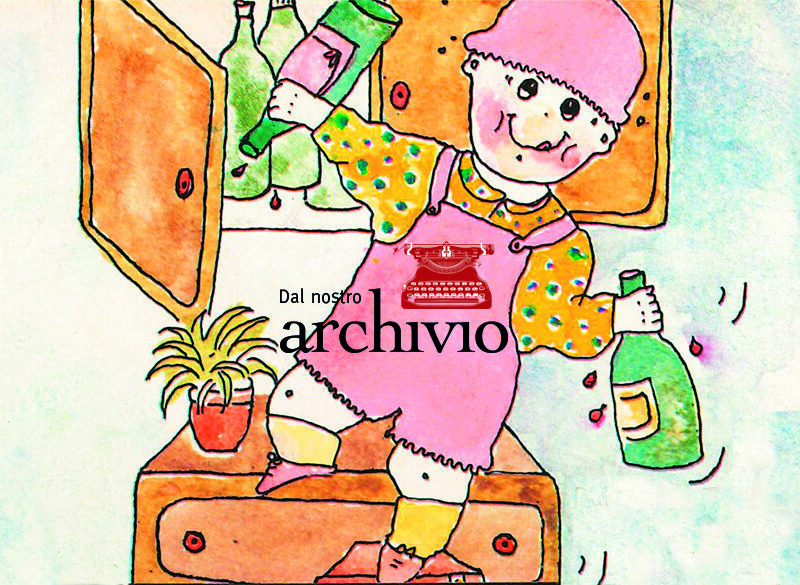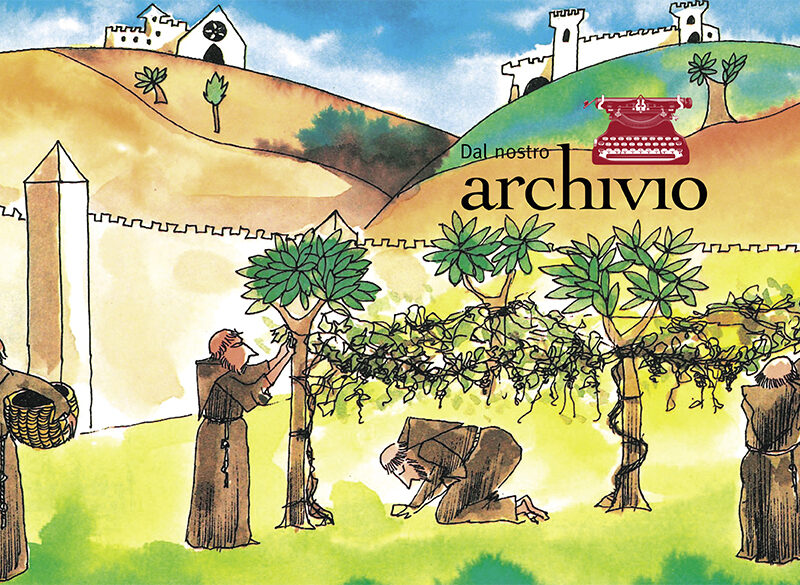Sfogliando i vecchi numeri della rivista, ci siamo imbattuti in una serie di servizi firmati da importanti scrittori dell’epoca, che vi riproponiamo anche per il loro valore letterario. In questo articolo il giornalista, romanziere e autore televisivo Guglielmo Zucconi ricorda la centralità del vino negli anni della sua formazione.
Ammiro i sensitivi che strizzando in bocca una lacrima di vino sanno estorcerle denominazione, annata, vigna, cantina e gradazione. Ma io credo che il vino vada assaggiato con l’anima. Per questo m’inchino al Barolo, al Recioto, al Corvo, alla Vernaccia, al Martinafranca e al Pinot Grigio, ma prediligo il Chianti e il Lambrusco. Il primo è il vino di mio nonno e delle mie vacanze, il secondo di mio padre e delle mie fatiche. Mio nonno Memmo nacque e visse in un paesino del Valdarno, Cancelli, zona del Chianti del putto, e quel vino, che egli “faceva in casa”, rappresenta per me il remoto sapore dell’estate perché appunto in quella stagione, fin dove si spingono i miei ricordi, mi vedo di fronte a lui, diviso da un bicchiere che sorseggia a intervalli e che di tanto in tanto mi porge dicendo: “Bevi bischero, che ti fa venire il nervo doppio”.
Il vino del mio clan
Quando ero molto piccolo, quel vino non mi piaceva: lo sentivo duro, non dolce, non frizzante e poi avvertivo in fondo come un sapore d’uovo. Ma facevo di tutto perché mi piacesse (come fatalmente accadde verso l’adolescenza) perché quello, capivo, era il vino del mio clan; mio padre, i miei zii, i miei cugini, erano stati svezzati col Chianti; alle mie cugine (le avevo spiate) col Chianti lavavano i sederini arrossati; a me, con un impacco di Chianti e trifoglio rosso avevano “curato i bachi”. Infine, un giorno, mentre accompagnavo mio nonno nella sua lenta passeggiata, incontrammo il medico condotto, altrettanto vecchio e cotto dal vino, che fermatosi a pochi metri da noi, alzò il bastone e gridò minaccioso: “Annacqualo, Memmo!”. Mio nonno, brandendo a sua volta il bastone come per vibrare un fendente rispose con fierezza: “Lo annacqui lei, dottore!”.
La fedeltà del nonno al Chianti
Mi parve un incontro tra due cavalieri antichi, di pari orgoglio, di uguale dignità. E come la madre di Brillat-Savarin che anche in punto di morte manifestò la sua fedeltà alla crème-caramelle, fece mio nonno col Chianti. Quando stava per avvenire il “pio transito”, accompagnato dalle preghiere e dalle lacrime di donne in nero, mia nonna si avvicinò al suo vecchio e gli sussurrò: “Memmo, che lo volete un gocciolin di vin Santo?”. Ed egli rispose: “Tenetelo per maggior bisogno. Per viatico basteranno due dita di Chianti”. Bevve, fece in tempo a chiedere: “Ma di che fiasco è?”, non udì la risposta e spirò sorridendo.
Il rapporto complicato con il Lambrusco
Quella del Lambrusco è una storia completamente diversa, meno romantica, più sofferta. Mio padre, nato in Toscana era emigrato in Emilia. A Modena conobbe mia madre e il Lambrusco. Amò la prima e accettò il secondo. Era – diceva – un vino per zittelle piscione, femmineo e imprevedibile come loro. Ma non potendo, con la sua paga da ferroviere, importare il maschio Chianti, si acconciò alla “gazzosina”, purché fatta in casa, ammostata con i suoi piedi, travasata con le sue mani. Gli uomini, secondo lui, si dividevano in tre grandi classi: i vinti, che bevono l’acqua, i lazzaroni che si avvelenano all’osteria, e i galantuomini che gustano in casa, “roba sana che si sa com’è perché la si è fatta”, brindando con la moglie e i figli. E a me, figlio, toccava, prima di bere, fare. S’intende, da facchino, da garzone-apprendista.
E me la son presa con gli astemi; accompagnino pure il loro pasto con l’acqua minerale, con l’acqua di sorgente, ma riconoscano con umiltà il loro difetto, non se ne vantino, e soprattutto tengano per sé la loro insipida virtù, senza pretendere d’imporla a tutti.
Però … Io che amo e bevo vino, non sono come quegli eccellentissimi bevitori che d’ogni assaggio che facciano riconoscono il tipo di vino e l’anno e il produttore; e vi dicono per esempio che un vezzosetto vino roseo che si fa a Castelvecchio di Sottoripa è quello che ci vuole per accompagnare les tripes à la mode de Caen (con les pieds de boeuf,non, orrore, con les pieds de veau), e non va confuso con un gagliardetto rosso che si fa a Castelnuovo di Sopraripa con il quale è assolutamente necessario associare un filetto di vitello alla siciliana, avvolto in due pendagli di lasagne.
Un occhio al cielo, l’altro ai prezzi
Verso la fine di settembre, quando i giorni erano ancora pieni di sole e di giochi, dovevo spesso interrompere guerre e partite perché incominciava la stagione della botte. Occorreva controllare e stagnare il tino, lavarlo, purificarlo con suffumigi di zolfo. Lo stesso con il bigoncio e la bigoncia. Poi le damigiane e i fiaschi, acqua calda e cenere. Poi le bottiglie, acqua fredda e pallini di schioppo. Infine, il controllo dei soppalchi e delle scansie della cantina. Succedeva la lunga attesa della vendemmia, con occhio al cielo e l’altro ai prezzi. E ogni anno la stessa lite in famiglia: mia madre spingeva a resistere finché “quei delinquenti dei contadini cedessero” col rischio di avere grappoli sfatti dalla pioggia; mio padre fremeva d’impazienza e avrebbe voluto comprare subito, col pericolo di pigiare uva ancora acerba. Il litigio si allargava al caseggiato, ai parenti, agli amici, perché tutti più o meno erano nelle stesse condizioni.
Il rito sacro della produzione
Finalmente, fatta la scelta, spuntava l’eccitante alba dell’uva ed io andavo incontro al contadino che arrivava col biroccio sul quale erano collocati, su due piani, i cestoni con quattro quintali d’uva (non di più, con “certi prezzi”!), un terzo di Grasparossa, un terzo di Salamino e un terzo di uva Brugnola, che valeva poco, ma costava meno di cento lire il quintale.La stagione del vino incominciava con la sacra lavanda dei piedi paterni e la liturgia continuava con le ispezioni serali al tino, coperto dal berrettone di vinacce sollevate dal mosto ribollente e incoronato dal nimbo sonoro dei moscerini; il travaso nelle damigiane; la unzione dei tappi; l’imbottigliamento; la speranza; la celebrazione.
E quello dell’assaggio della prima bottiglia
Al momento di aprire la prima bottiglia, mia madre raccomandava a me e a mia sorella silenzio e compostezza. Era come essere in chiesa all’atto dell’elevazione, quando mio padre, sollevato il primo mezzo bicchiere contro la luce, dichiarava: “È cristallante, sembra rubino”.
Poi l’assaggio, riservato dapprima al gran sacerdote che con gli occhi al cielo, distillava, palpeggiava, scomponeva tra lingua e palato le specie del vino. Infine la sentenza, sempre diversa ma sempre volutamente provocatoria: “È abboccato… è maccherone… ha il formichino… non ha la viola…”. A quel punto toccava a noi fedeli accostarci al vino, assaporarlo e in coro rassicurare l’officiante: è il miglior vino che tu abbia mai fatto!
La lunga quaresima delle vinacce
Ma dopo il momento di gloria, incominciava la lunga quaresima delle vinacce. Assicurate le duecento bottiglie di vino buono, per la domenica, le altre feste e gli ospiti, le vinacce ancora generose, si maritavano con l’acqua e davano il “vin sopè” (vin-à-souper) leggero, frizzante, ottimo per la tavola soprattutto nella stagione calda. Poi, ancora bigonce d’acqua che scrosciavano sulle vinacce ormai esaurite per produrre il “vino sottile”: terzanello, quartanello, quintanello. Un anno particolarmente siccitoso con una uva cara ma gagliarda, “bevemmo dietro le vinacce” fino a Pasqua, giungemmo al sestanello.
In questo periodo occorreva davvero una robusta fede per continuare a credere nel vino e nei suoi discendenti. Ad ogni nuova e sempre più scolorita risciacquatura di vinacce, mio padre ne portava in casa un fiasco, riempiva il primo bicchiere, contemplava a lungo l’acquetta violacea e dichiarava perentorio: “Acqua non è, gustacci non ne ha…”. E noi dovevamo rispondere che era buona davvero, onesta e rinfrescante. Non era vero e lo sapeva anche lui, ma tutti sapevamo anche che i soldi per comprare l’uva necessaria non c’erano. Perciò era indispensabile fingere; per continuare a sentirci una famiglia fortunata e felice, nemica tanto dei bevitori d’acqua, quanto degli alcoolizzati d’osteria.
Ed ogni anno, prima durante e dopo la stagione dell’uva, del vino e delle vinacce, mio padre mi faceva giurare che anch’io da grande, avrei fatto il vino in casa. L’ho tradito. Ma anche per questo prediligo il Chianti e il Lambrusco: bevo col rimpianto, bevo col rimorso.
Guglielmo Zucconi (1919-1998), giornalista, scrittore, autore televisivo e radiofonico bolognese