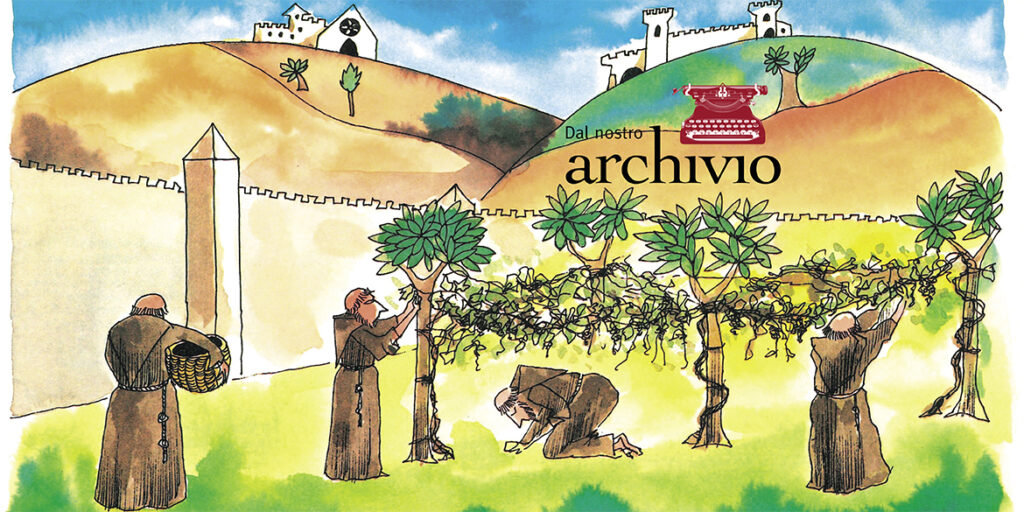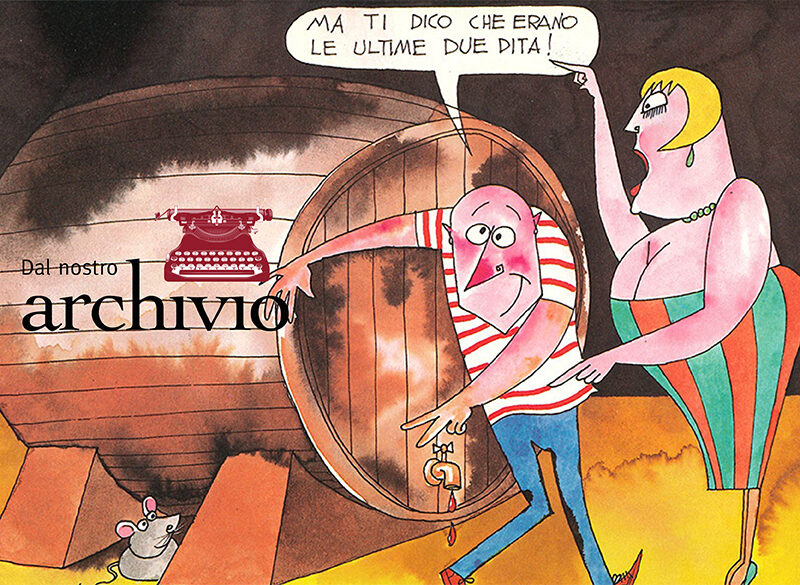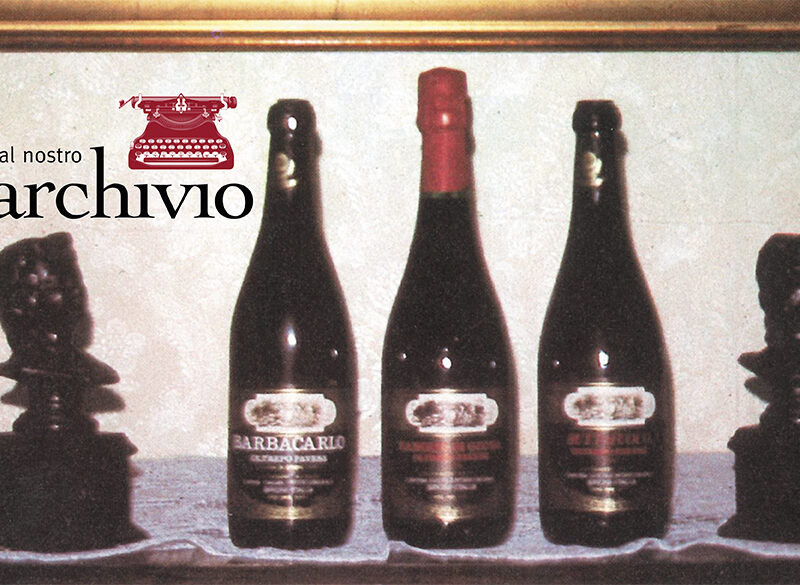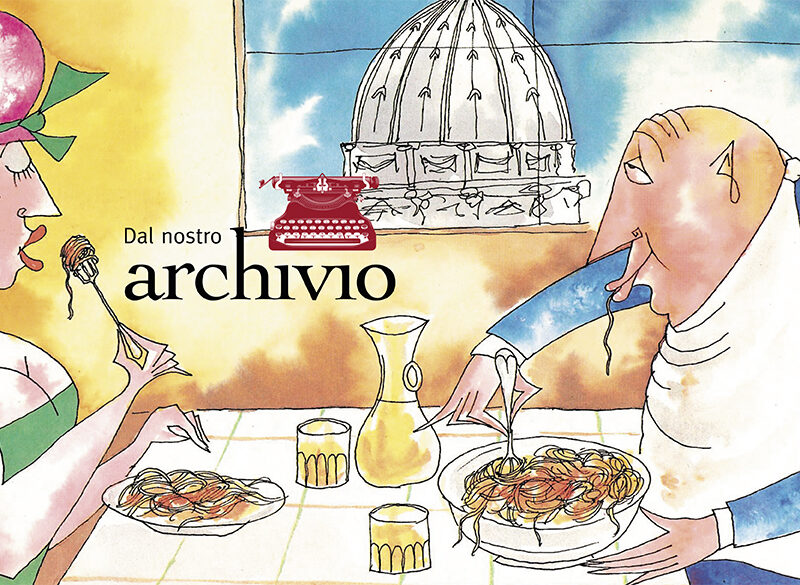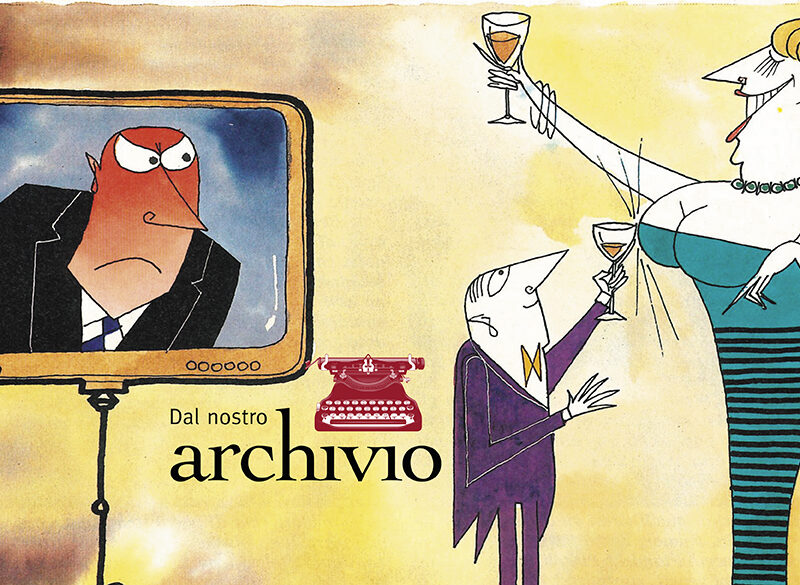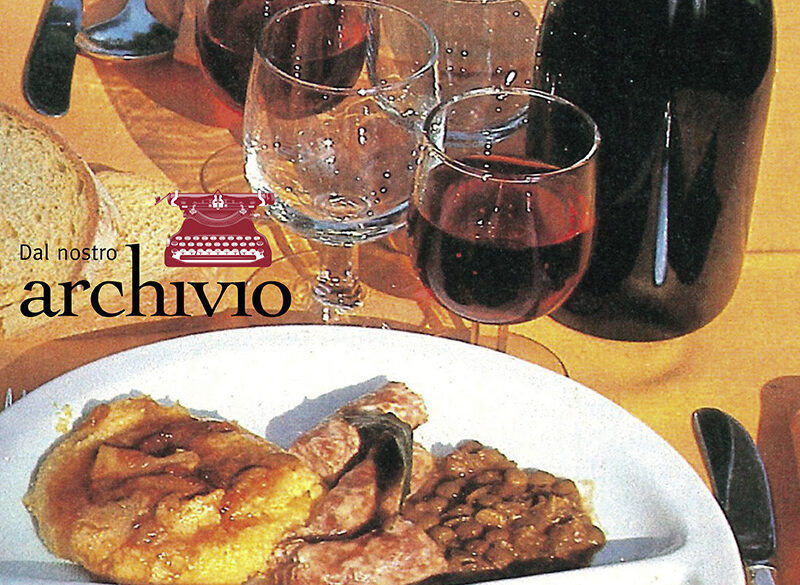In questo articolo del 1981 vengono ripercorsi i momenti difficili attraversati dalla viticoltura europea durante i cosiddetti secoli bui, “quando le invasioni barbariche inondarono il continente di fiumi di birra, ma prima che Chiesa e Medicina decretassero il suo ritorno glorioso”
Da che mondo è mondo, ogni epoca ha cantato le lodi del vino, il suo gusto inimitabile, quell’incomparabile capacità di esaltare l’animo umano e trasformare il piatto più umile in cibo per gli dei. Ma, fra tutti i periodi della storia passata, il Medio Evo è forse quello che ha apprezzato con maggiore entusiasmo il vino e le sue virtù, celebrandolo immancabilmente in poesia e in prosa, nelle arti e nelle scienze.
È vero che i pionieri erano stati, nel mondo antico, Greci e Romani, che già avevano sperimentato gran parte delle tecniche di coltivazione e di vinificazione. Ma il sopravvivere dell’amore per il vino, insieme alla conoscenza dei sistemi migliori per produrlo, è un retaggio che dobbiamo quasi esclusivamente agli uomini del Medio Evo. Osservando le vaste aree vocate alla viticultura nell’Europa moderna, chiunque potrebbe immaginare che questo rapporto fra la gente e la vigna – così radicato ed antico – non abbia mai corso alcun serio pericolo. Ma si tratta di un’impressione sbagliata, perché questa dedizione nei confronti del vino fu messa a dura prova nel momento in cui l’Europa passò dal mondo antico a quello medioevale.
La birra e l’idromele “barbarici”
A contendere al vino il favore degli Europei arrivò la birra nelle sue due versioni, chiara e scura, e si rivelò, sin d’allora, una grande antagonista. In principio, d’altronde, il vino aveva anche un altro “contendente”, l’idromele, ottenuto dall’evaporazione e dalla fermentazione del miele. La birra e l’idromele erano le bevande abituali dei barbari provenienti da Nord e da Nord-Est, sebbene avessero un certo seguito anche fra le popolazioni della civiltà greco-romana. Gli Egiziani, in particolare, e qualche altra nazione del Medio Oriente bevevano regolarmente birra ma, ciò nonostante, il vino continuava ad essere prodotto, bevuto e persino esportato in Grecia, in Italia e in altre regioni occidentali dell’Impero Romano. In ogni caso, né la birra né l’idromele rappresentavano una seria minaccia alla supremazia del vino nel mondo antico.
Lo sviluppo della vite a Nord
Le tribù barbare, invece, sapevano a malapena della sua esistenza. Nei loro territori non cresceva uva adatta ad essere vinificata. Alcuni, naturalmente, conoscevano il vino e se lo procuravano attraverso scambi con l’Impero, occasionalmente, durante i saccheggi. Ma un simile contatto era per sua natura sporadico e limitato; i barbari, in grandissima maggioranza, sguazzavano felici nella birra ed il pensiero di poter perdere l’occasione di una nuova, gratificante esperienza, sembra non li sfiorasse affatto.
Sebbene dunque questi tracannatori di birra ignorassero il vino – ed è probabile che non lo avrebbero apprezzato neanche conoscendolo meglio – i “rinforzi” erano in arrivo: dal 50 a.C. al 50 d.C., infatti, nell’area della Valle del Rodano cominciarono a svilupparsi vitigni capaci di resistere in quel clima freddo e umido. Prima d’allora, generalmente, i tentativi di coltivare uva da vino a Nord della Provenza, dell’Aquitania e della Linguadoca erano stati coronati da scarso successo. Ora queste nuove varietà, più vigorose, si diffusero rapidamente verso Nord, estendendosi, intorno al IV secolo, fino alla Mosella e alla Valle del Reno. E all’epoca in cui i barbari cominciarono le loro scorrerie che concorsero a provocare la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, i vigneti erano già stati messi a dimora anche in Austria e in Svizzera.
Condizioni difficili per coltivare la vite
La maggior parte degli storici ha passato il tempo nel silenzio polveroso delle biblioteche indagando sulle cause ultime che resero possibile il crollo dell’Impero Romano e il sorgere, in Occidente, di regni barbarici e principati. Ma sono stati in pochi ad osservare che queste invasioni decretarono anche il trionfo dei bevitori di birra e di idromele.
In quella moltitudine tutta presa dai suoi passatempi preferiti, rapine, massacri, razzie, era abbastanza difficile, in effetti, trovare qualcuno disposto a piantare la vigna o a sorvegliare ansiosamente i tini di fermentazione. E costoro resero la vita difficile, a dir poco, a quelle anime tranquille che desideravano soltanto “allevare” la vigna. Se il vitigno, infatti è una pianta resistente, il vigneto, purtroppo, è una creatura fragile. L’intero processo, dalla messa a dimora delle barbatelle alla vendemmia, si presenta realmente complicato, richiede duro, tenace lavoro, una buona dose di nozioni e di esperienza, un apprezzabile investimento di capitali ed un bel po’ di tempo. Ma bisogna riconoscere che eran condizioni difficili da trovare in quel periodo di disordine e di disgregazione che segnò il crollo della civiltà occidentale. E così la viticoltura cominciò a decadere.
Il ruolo della medicina e del Cristianesimo
A salvare la situazione intervennero due grandi “potenze”: il giudizio della medicina e la pratica religiosa. Ippocrate (o quei dottori rimasti ignoti che compilarono la summa di trattati fondamentali che porta il suo nome) aveva insistito ripetutamente sulle virtù del vino, come alimento e come medicina. Era utile al corpo e all’anima, necessario alla salute e al buonumore quanto il cibo, la ginnastica e la pulizia. Un tipo di persuasione che farebbe la gioia di una moderna agenzia di pubblicità. Anche oggi, tranne qualche recente “cavillo” da parte medica questa teoria trova ancora molto seguito. La Chiesa, in Occidente, mantenne viva l’antica tradizione della medicina, diffondendo l’uso del vino con altrettanta perseveranza, come parte della formula rituale per la salvezza dell’anima. I due elementi fondamentali dell’Eucarestia – pane e vino – furono scelti di proposito, senza dubbio, per la loro importanza vitale nella dieta antica.
L’acquisto di vigneti da parte della Chiesa
E su questo punto essenziale, la Chiesa non è mai venuta a compromessi. Nella liturgia protestante si può anche aver usato del succo d’uva, ma il Cattolicesimo ha sempre insistito sul succo fermentato, anche nei Paesi che non producono vino. In certe zone dell’Africa tropicale, ad esempio, dove tradizionalmente si beve vino di palma, i missionari hanno chiesto ripetutamente il permesso di usare questa bevanda locale dell’Eucarestia. Ma la preghiera non è mai stata accolta. E fino ad ora lo stesso principio è osservato anche in Oriente, sebbene qui abbia larghissima diffusione il saké, “vino di riso”.
Con queste premesse, dunque – diventato il vino un prodotto raro nel periodo caotico delle invasioni barbariche – fu inevitabile, per le chiese locali, cominciare ad acquistare vigneti. È vero che già nel mondo antico la Chiesa aveva posseduto vasti terreni, ma allora questi le servivano soprattutto come fonte di reddito o come rifornimenti in natura per grandi beneficenze. In ogni caso a quei tempi il vino era venduto tranquillamente sulla piazza del mercato, e il problema non esisteva proprio.
San Benedetto e San Colombano
Quando, nei Secoli Bui, la viticoltura decadde e il commercio cominciò ad essere precario, ciascuna chiesa dovette badare al proprio fabbisogno. Il metodo più sicuro era quello di far tutto da sé: coltivare la vite e produrre vino. E dal momento che possedevano mezzi e manodopera costantemente a loro disposizione, gli ordini monastici divennero nel Medio Evo la classe di viticoltori e vinificatori per eccellenza.
Fra le collezioni di libri raccolte nei monasteri, i monaci trovarono anche i vecchi trattati d’agricoltura del mondo antico e presero a studiarli, migliorando la tecnica in campo enologico. Così, a loro volta, divennero maestri dei viticoltori laici, tanto che oggi, portando alle labbra un buon bicchiere, si dovrebbe sentire nei loro confronti un briciolo di riconoscenza. Comunque questo revival della viticoltura non fu portato a termine senza una lotta fra due distinte tradizioni. Vinse quella latina, i cui monaci si riunirono nell’Ordine dei Benedettini, istituito in Italia già nel VI secolo. A perdere fu la regola di S. Colombano, sorta nello stesso periodo.
Uva batte malto
San Benedetto era un uomo di antiche tradizioni e decise che il vino sarebbe stato per i monaci la bevanda usuale. Perciò, nel suo Ordine, egli fece in modo che non dovesse mai mancare. Colombano e i suoi seguaci, invece, che fondarono monasteri in tutta Europa, erano Irlandesi abituati a bere birra tutti i giorni, anche se per la Messa usavano certamente il vino. Ma si trattava di un consumo minimo, limitato com’era alla sola liturgia, e la birra rimaneva la bevanda “ufficiale”.
Per questo motivo, c’è chi sostiene che il trionfo della regola benedettina non significò soltanto il predominio della cultura latina su quella celtica, ma anche del vino sulla birra. Il parallelo è forse un po’ forzato ma c’è, senza dubbio, qualcosa di vero. Certamente, anche in certi monasteri benedettini dell’Europa settentrionale e in Gran Bretagna si preparava dell’ottima birra (qualcuno, specialmente in Belgio, ne produce tuttora); ma, in generale, l’immagine del monaco – e c’erano mille occasioni per constatarlo – si associava naturalmente a quelle delle botti di vino, come quella del bicchiere alla bottiglia.
Il problema della conservazione
La produzione, il trasporto ed il commercio del vino divennero in breve una delle principali attività economiche. Ma, nonostante, l’entusiasmo con cui l’accolsero gli Europei, diversi fattori – molti, in verità, fuori dalla portata degli uomini d’allora – testimoniano che i vini dovevano essere di gran lunga inferiori alla maggior parte delle annate mediocri di oggi.
Il problema fondamentale era come conservarli. La bottiglia di vetro – che divenne d’uso comune solo nel 1500 – era allora praticamente sconosciuta. Di solito, i vini fermentavano in enormi botti e lì venivano lasciati oppure travasati in altri barilotti, anche questi di grandi dimensioni. Si trattava sempre di contenitori di legno e anche in quelli fabbricati con maggior perizia, certe perdite dovute ad evaporazioni erano, ovviamente, del tutto inevitabili. I Greci ed i Romani antichi avevano risolto in parte il problema dei recipienti usando vasi di terracotta, come le anfore, che ricoprivano con diverse sostante impermeabilizzanti. Una mano di smalto trasparente, e questi vasi sarebbero diventati a prova di aria e di acqua, ma questo era un sistema troppo costoso. Conveniva piuttosto ricoprirli di pece o di qualche altra sostanza simile che, naturalmente, cedeva al vino un po’ del suo sapore. E i beoni di allora, alla fin fine, ci presero gusto al punto di aggiungere di proposito un po’ di resina o pece al vino, anche quando non ce n’era bisogno.
Invecchiamento uguale acidità
Al giorno d’oggi, soltanto i Greci conservano ancora questa predilezione per i vini resinati.
Esposti com’erano all’azione dell’ossigeno dopo la fermentazione del mosto, i vini medioevali continuavano a fermentare anche in botte e inacidivano piuttosto rapidamente nell’arco di circa sei mesi dal raccolto. E dal momento che in Europa il periodo abituale della vendemmia può variare dall’inizio di settembre alla fine di ottobre, quei vini, in genere, cominciavano a divenire imbevibili verso la metà o la fine di maggio. Dopo di che erano semplicemente troppo acidi, tranne forse per chi, spinto dalla disperazione, si turava il naso e tracannava tutto d’un fiato il contenuto della sua coppa. Capitava di rado, a quei tempi, che un cantiniere riuscisse a conservare intatte le qualità di un vino sino alla vendemmia successiva. Anche la letteratura dell’epoca è tristemente muta in proposito, a testimoniare che la pienezza e l’eleganza di un sapiente invecchiamento erano ancora cose sconosciute. Nel Medio Evo, in pratica, un vino stagionato altro non era se non una bevanda inacidita.
Come fiori in boccio
Stando così le cose, è naturale che si cominciasse a berlo appena possibile, spesso nel giro di poche settimane dalla vendemmia. Non aveva senso aspettare che si sviluppasse, acquistasse carattere e un bouquet più sofisticato. I vini erano condannati a fiorire ed appassire in fretta, e gli intenditori di allora non disdegnavano certo di cogliere quei fiori in boccio al momento opportuno.
Con un prodotto così deperibile, non ci si potevano permettere indugi. Carri e guidatori, navi e portuali dovevano essere sempre organizzati e pronti ad entrare in azione quando e dove ce ne fosse bisogno. Se un carico subiva un ritardo nel raggiungere il molo, e la nave non riusciva a partire prima dell’inizio dell’inverno, capitava che restasse bloccata in porto fino a primavera. A quel punto, la qualità del vino era ormai compromessa e la sua “probabilità di vita” estremamente limitata. E il mercante poteva vedersi costretto a cancellare l’intera spedizione.
Il trasporto per mare
Il sistema di trasporto migliore, a qualsiasi distanza, rimaneva comunque la navigazione. Era più conveniente, più veloce e meno complicato, a quei tempi, dei mezzi usati sulla terraferma. Secondo Roger Dion (che ha scritto alcune eccellenti opere sulla produzione ed il commercio del vino nel Medio Evo) i grandi vigneti non potevano che trovarsi in prossimità del mare, di laghi o di corsi d’acqua navigabili. I vini prodotti in zone circondate dalla terraferma servivano per il consumo locale ma non erano conosciuti né tantomeno commercializzati a grandi distanze.
È vero che durante il Medio Evo i trasporti su strada avevano subìto grandi migliorie. Innanzitutto, era stato introdotto dall’Oriente un nuovo tipo di bardatura. Gli antichi Greci e Romani usavano due cinghie di cuoio: una intorno al collo del cavallo e l’altra come sottopancia. Ogni volta che l’animale avanzava, il soggolo gli tagliava la iugulare e la trachea, limitando molto la sua capacità di trascinare pesi. Con i nuovi finimenti, dotati di un collare rigido, il cavallo poteva dare anche lui una mano alla baracca, per così dire, quadruplicando la sua potenza di traino.
E quello via terra
La ferratura degli zoccoli – divenuta pratica comune nell’Alto Medio Evo – contribuì anch’essa ad accrescere la resistenza dell’animale al duro lavoro nell’umido e nel fango. In ogni caso, trascinato da cavalli o da un tiro di muli, il carro rimaneva per le merci un mezzo di trasporto lento, pesante e costoso. Nello stato di grave abbandono in cui erano ridotte le strade nel Medio Evo, soltanto la ghisa avrebbe potuto resistere agli urti, ai sobbalzi, alle scosse di un lungo viaggio. Ma i barili erano sicuramente più fragili del ferro e le doghe perdevano continuamente durante il tragitto, tanto che gli spedizionieri per solito assumevano un falegname per scortare il convoglio e riparare le botti ad ogni sosta lungo la strada. E falegnami e bottai accompagnavano anche le spedizioni per mare.
La pratica della colmatura
Anche conservati in cantina, i fusti erano sottoposti ad un controllo costante ed ogni perdita dovuta a filtrazione o evaporazione era reintegrata per ridurre il più possibile il contatto del liquido con l’aria. Bisognava tener da parte una gran quantità di vino per questa operazione, specialmente durante il trasporto.
Nei 174 chilometri di viaggio da Saint Pourçain a Chalon-sur-Sâone, ad esempio, ogni 15 barili ne veniva usato uno per colmarli. I 30 chilometri che separano Beaune da Sâone causavano una perdita di un barile soltanto ogni 25, 50 o anche 100 trasportati. Il singolo fattore della perdita dovuta alla spedizione, perciò, ci assicura che il vino di St. Pourçain dev’essere sempre stato più caro di quello di Beaune. La colmatura si rendeva necessaria anche durante il trasporto per mare, specie quando il tempo cattivo metteva alla prova le doghe. Ma la percentuale che andava perduta in una normale traversata è minuscola a paragone degli sprechi sulla terraferma.
Ovviamente, dal punto di vista del consumatore e sulla base dei soli costi di trasporto, era meglio vivere in una città di mare di un Paese non produttore di vino, piuttosto che abitare a 150 chilometri di distanza dal più vicino distretto vinicolo. E sempre il fattore costo è responsabile della tendenza del vino, come l’acqua, a scendere a valle. Era semplicemente troppo costoso pagare carrettieri e noleggiare animali per trascinare pesanti barconi contro corrente. Vedremo in un prossimo articolo come vinai e commercianti s’ingegnarono per render possibile il trasporto del vino.
James M. Johnson