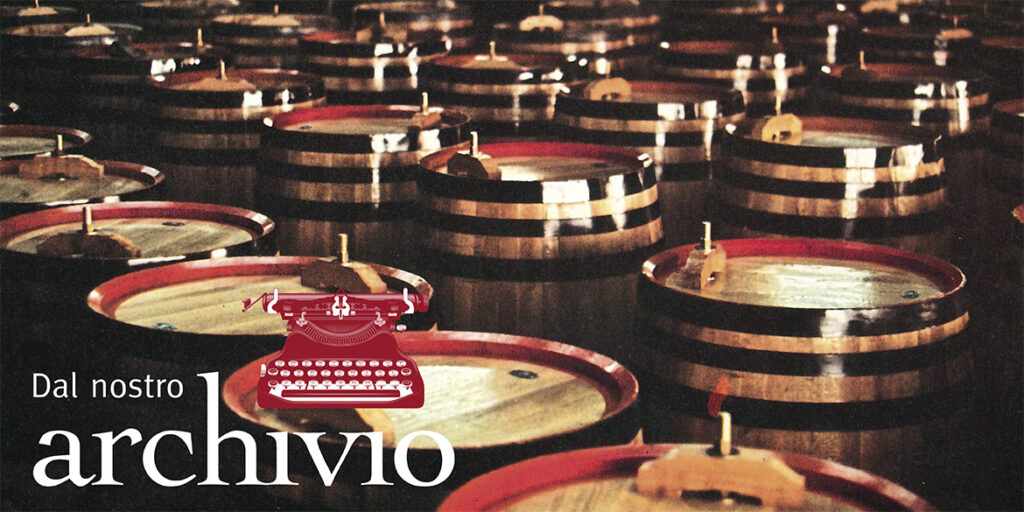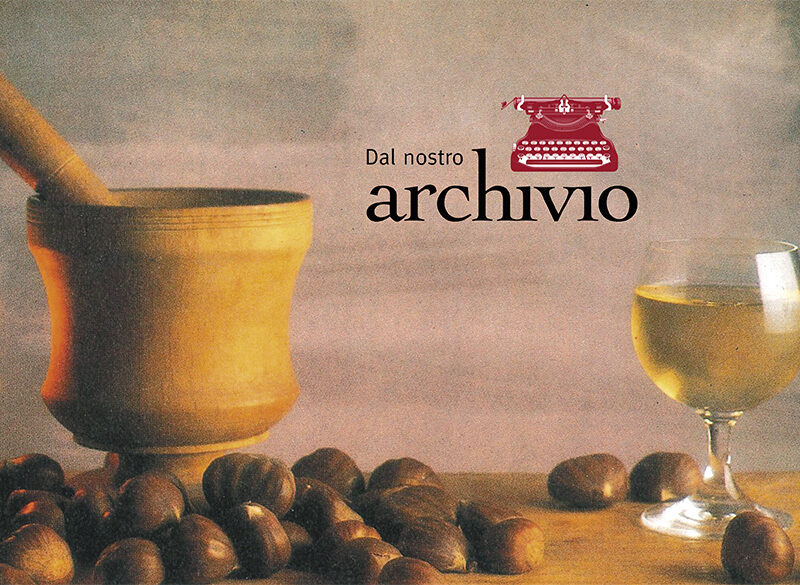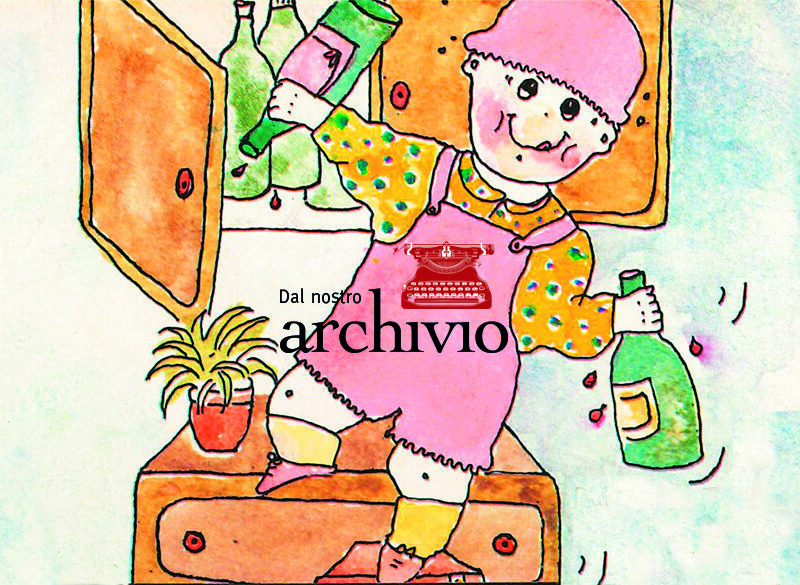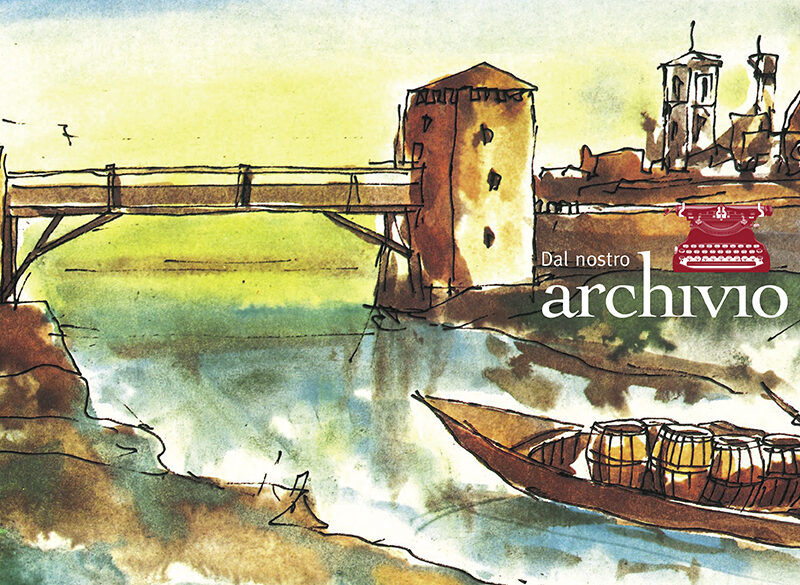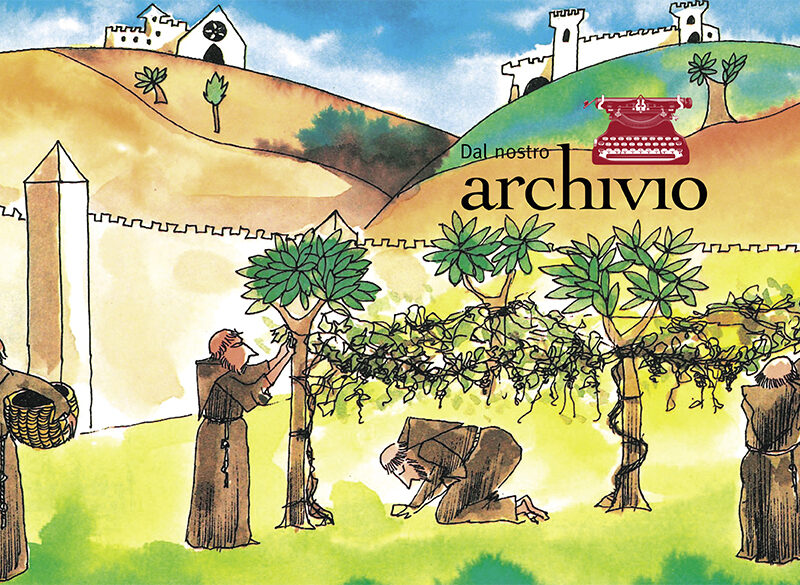In questo articolo dell’inizio degli anni Ottanta, il celebre enologo Giacomo Tachis ci ricorda la sottile ma sostanziale differenza tra maturazione e invecchiamento, spiegando perché il passaggio in legno (grande o piccolo) non sia sempre e comunque una buona idea e quali sono i fattori da valutare.
La parola “invecchiamento” esprime in genere qualcosa di malinconico o addirittura triste. Malinconico, se si pensa alla vecchiaia; triste se si pensa che dopo il tramonto viene la notte… Nel vino non è proprio così, ma quasi. A mio avviso, quando si parla di vino, il termine “invecchiamento” non è del tutto valido, perché il processo che interessa all’uomo cui piace il vino nel momento migliore della sua vita fisiologica è quello della “maturazione”, stadio però che in pratica viene interpretato come “invecchiamento”, oppure viceversa.
Differenze da cogliere
In realtà la maturazione rappresenta una fase che è antecedente a quella dell’invecchiamento e ad esso si collega direttamente, tanto che molto spesso scivola addirittura confondendosi con esso. Ma il vino per essere sfruttato nelle sue qualità migliori dovrebbe essere consumato sul finire della maturazione e prima dell’invecchiamento fisiologico, salvo casi eccezionali. Non vorrei confondere le idee con questa mia affermazione, né dare l’impressione che io sono contro l’invecchiamento del vino… Se c’è un lavoro in cantina che m’appassiona è proprio questo; ma voglio precisare soltanto che c’è differenza tra maturazione organolettica e vino vecchio: vecchio, ma buono; spento, passato, è invece un altro discorso.
Una questione di sensibilità
Il momento giusto in cui il vino dovrebbe andare al consumo non è tanto facile a stabilirsi, proprio perché non esiste una regola fissa applicabile con metodi di analisi chimica o chimico-fisica che permetta di determinarlo. È solo la sensibilità umana, confortata certamente dai dati suddetti, ma in forma minoritaria. Sono gli occhi, il naso e il palato che devono “scorgere” il momento giusto. In poche parole, è l’uomo che deve “giudicare e determinare”. Sì, per fortuna, l’uomo è ancora insostituibile: la natura non sostituirà mai sé stessa; la natura – senza alcuna allusione – sa farsi intendere da sola senza il pur utile, direi indispensabile ausilio del laboratorio più o meno attrezzato di strumenti, folto di persone e ricco di reagenti chimici.
Un ciclo naturale
L’uomo studia per comprendere e penetrare la natura. Infatti succede abbastanza sovente a me, che faccio l’enologo, di sentirmi dire dai cantinieri che questo vino è “da bersi” o da “imbottigliare” o già “passato”, oppure “non è ancora pronto”: essi non conoscono neppure la formula dell’acqua, eppure quasi sempre le loro opinioni tornano con i miei conti enologici. Quando si parla di invecchiamento del vino bisogna pensare ad un ciclo di evoluzione positiva, ad un processo che lo porta all’apice delle sue possibilità organolettiche, ma non ad un calo di qualità perché “invecchia”. Il vino, liquido fisiologico, si presta allo studio e al controllo di questo ciclo, ma non dimentichiamo che per ora il “gustametro” non esiste ancora nelle nostre cantine e inoltre la tipologia del gusto è variata e varia continuamente, spostandosi – mi sembra – verso un parametro veramente migliore.
Cambio di paradigma
Come è cambiata l’immagine del vino da bottiglia millesimata da dieci-quindici anni a questa parte!
Il pensare che il valore organolettico di un vino si otteneva soltanto mettendolo a invecchiare in una botte di legno è variato proprio perché è variato il “parametro organolettico” di esso (colore-profumo-sapore) e la bottiglia di vecchia annata che conteneva vino rosso-arancio a profumo di svanito o quasi, sapore tra il vecchio, il passato e a volte il maderizzato-acidulo, corpo scarno e breve, direi quasi “ex-vino”, oggi non è più apprezzata. Il vino moderno da bottiglia millesimata deve essere giustamente maturo, ma non vecchio di sapore, di colore, di profumo. Non è per dire bene di alcuni concorrenti stranieri, ma bisogna riconoscere che queste cose le abbiamo imparate molto da loro, oltre che da una autocritica dei nostri palati; e mi sa che alcuni Disciplinari non reggano più il passo con tali evoluzioni.
Acido citrico e acido tartarico
Da queste considerazioni nasce tutto un rivoluzionamento della tecnologia non solo dell’invecchiamento del vino, ma dei criteri di vinificazione, di conservazione, di stabilizzazione e di messa in bottiglia. Tempi addietro ma non troppo, almeno qui in Chianti, l’acido citrico e l’acido tartarico erano le “polverine principali” che l’enologo, quasi a mo’ di stregone, faceva aggiungere al vino, naturalmente insieme a un pizzico di metabisolfito, durante le fasi di conservazione in botte, o in vasca, e prima dell’imbottigliamento.
Non è che oggi questi prodotti non si impieghino più, perché il principio è sempre valido, ma il criterio del loro uso è variato, si è evoluto e quasi tutti cercano di esaminare in via cromatografica o enzimatica la gocciolina di vino, per controllare se davvero ha bisogno di aggiunta di acidità o se già ne ha troppa, oppure se il metabisolfito che si dovrebbe aggiungere non impedirà la fermentazione malolattica, se ancora non è ultimata…
Non sempre la botte fa bene
Il collocare il vino nella botte di legno pensando che essa migliorerà senza meno, è troppo facile o sarebbe troppo facile, per giungere ad un soddisfacente risultato qualitativo del prodotto.
Io sono convinto che a volte la qualità di alcuni vini rossi peggiora in botte principalmente per due motivi:
– perché a certi vini rossi non si addice la conservazione in legno anche se è della qualità migliore e in ottimo stato di conservazione; oppure, per alcuni di essi, basterebbe un periodo molto più breve di sosta in legno;
– perché in caso ancora diverso dal precedente, anche se il vino era adatto a invecchiarsi in legno, la qualità della botte non andava bene (legno troppo vecchio, imbibito di solfati, oppure botti non buone per la qualità poco valida del legno).
Conta anche l’andamento dell’annata
Se consideriamo a fondo queste cose, ci possiamo anche rendere conto come alcuni Disciplinari siano in parte incompleti dal punto di vista tecnico. Non tutte le annate, anche tra quelle considerate buone, possono dare vini adatto alla botte o comunque anche se adatti, il periodo di adattabilità, per così dire, varia da una vendemmia all’altra. Prendiamo l’annata 1975 in Chianti.
Il vino era piacevole e piuttosto considerato, ma la sua vita in botte è stata breve e la qualità migliore di esso si è ottenuta passandolo in vetro con una certa precocità. La stessa cosa mi pare che stia succedendo anche con il 1977. Con questo non si intende dire che le due annate succitate sono di poco valore: il “buono organolettico” si ottiene in tanti modi; basta saperlo ottenere, considerando che le regole in enologia hanno una fondatezza assoluta in linea di principio, ma devono applicarsi con l’elasticità del caso.
Le alternative al legno
Per lungo tempo i contenitori di legno sono stati il sistema più comune per immagazzinare il vino sfuso e anche oggi per ragioni molto svariate, si può ritenere che essi ancora lo siano, almeno dal punto di vista tradizionale e psicologico specialmente da parte del consumatore e del produttore legati al passato. Per fortuna però i manufatti in cemento, in acciaio al carbonio rivestito, in acciaio inossidabile, hanno preso notevole sviluppo e hanno soppiantato parzialmente il legno apportando diversi vantaggi di ordine tecnico ed economico.
Ma un vantaggio notevole, data la scarsità e il prezzo del legname, è stato quello indiretto: con la minore richiesta di contenitori in legno, il loro uso è stato riservato più che altro per i vini di pregio e la quercia può essere impiegata, diciamo così, in “esclusiva” nella sua qualità migliore per l’invecchiamento dei vini di alta qualità.
L’uso della barrique nuova
Questo fenomeno si è verificato un po’ in tutte le parti del mondo vinicolo e principalmente in Europa. Infatti oggi l’impiego del legno per fusti e botti da invecchiamento è limitato quasi del tutto al Quercus Robur e seppure la richiesta di botti a media e grande capienza specialmente in Italia sia ancora corrente, il concetto di conservazione dei vini da invecchiamento per la loro evoluzione in legno, si accosta al modello di contenitore piccolo, e per lo più in legno nuovo.
In conseguenza di un allargamento del raggio di impiego di questo sistema per i vini rossi italiani, che attualmente sostano in botti di legno a piccola o media o grande capienza nuove o non nuove, i produttori probabilmente si troveranno dinanzi ad alcune sorprese, proprio perché tale sistema di invecchiamento è estremamente selettivo ed esigente nei riguardi del vino rispetto all’attuale e tradizionale metodo di conservazione. E è anche più costoso…
Gli effetti della barrique
Non sembra inutile infatti ripetere che buona parte delle nostre cantine che serbano il vino in botte per l’invecchiamento, non è che evolvano il vino, ma lo conservano, invecchiandolo più o meno secondo il tenore di ossigeno che passa in esso in funzione del tempo di conservazione, della capienza della botte, del suo dispositivo di chiusura, del suo stato di manutenzione, del clima di cantina e dei travasi e via dicendo. Ma tutto sommato – questa non è ironia – è quasi meglio, perché se tutti i vini che in Italia si intende invecchiare in botti di legno (anche come previsto addirittura da alcuni Disciplinari) dovessero veramente andare in piccola capienza nuova, solo pochi ne sarebbero avvantaggiati qualitativamente, mentre la più parte ritengo che ne avrebbe il peggio.
I fattori da considerare
Per creare le condizioni da invecchiamento ad un vino rosso, premesso che il suo corredo polifenolico sia adatto dalla nascita, bisogna tener conto di alcuni fattori principali:
– biologico: completamento dei movimenti biologici-principali e secondari (fermentazione alcolica e malolattica) assenza di infezioni batteriche di qualsiasi sorta
– chimico e chimico-fisico: in parte questo è conseguenziale della fermentazione alcolica e malolattica, come lo spostamento delle acidità (pH), precipitazione dei sali minerali, ecc. Particolare influenza rivestono le sostanze fenoliche sulla qualità del vino e sul comportamento della botte (cioè del legno).
Tutte le trasformazioni delle sostanze fenoliche incidono sui caratteri organolettici del vino: vedi il rapporto aggregazione e polimerizzazione dei tannini/astringenza del vino; polimerizzazione antociani del vino/colore (anche polimerizzazione tannini/colore); il processo ossidazione/rapporti con composti fenolici, eccetera.
La quantità di sostanze fenoliche
Per questa ragione un vino soggetto a considerevole ossidazione, come accade di norma durante una più o meno lunga conservazione in piccole botti o fustame, deve avere un contenuto fenolico iniziale piuttosto elevato per sopravvivere in buone condizioni al processo. Ecco perché, dicevo prima, in certo senso è salutare per tanti vini nostrani, scarsi in queste sostanze, che il produttore conservi il vino in botti a media e grande capienza, ritenendo così di invecchiarlo; il che rappresenta una via intermedia fra lo stoccaggio e il tentativo di invecchiamento. E non è male!
Meglio ancora sarebbe se conservasse in tino di acciaio epossidicato o formofenolizzato o di acciaio inossidabile oppure in vasca di cemento con superficie interna epossidicata (sempre ottimo mezzo di stoccaggio): in questo modo il suo contenuto tanninico rimarrebbe più a lungo invariato, data l’impermeabilità del contenitore, che lo preserva di più dalle ossidazioni e che costa meno della botte in Rovere e non provoca tanti cali. (Vedremo in un prossimo articolo le caratteristiche tecniche delle botti per l’invecchiamento). Infatti a causa degli alti prezzi delle botti nuove di buona qualità, delle spese extra per l’aumento del costo del lavoro e delle perdite per evaporazione legate all’invecchiamento in botti di legno, l’interesse tecnico ad adottare tali sistemi di evoluzione deve focalizzarsi soltanto sui vini per i quali ne vale veramente la pena.
Giacomo Tachis (1933-2016), tra i maggiori enologi italiani, padre dei SuperTuscan, del Turriga, del San Leonardo e di molti altri vini-mito italiani