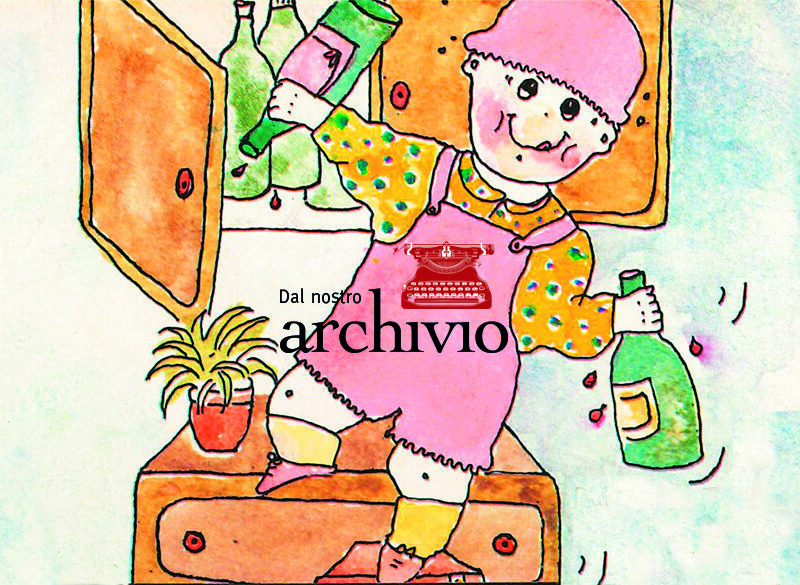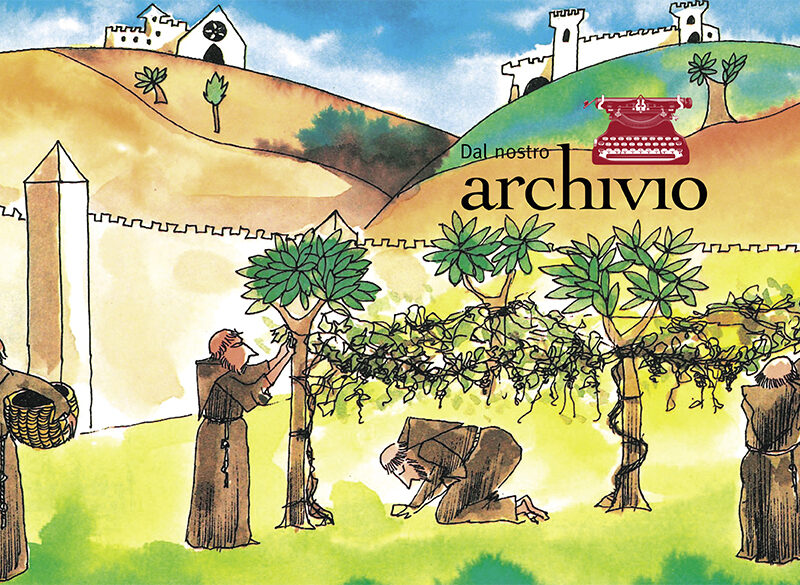Sul quarto numero di Civiltà del bere il giornalista e critico gastronomico Massimo Alberini ci invita a riflettere sul tema “Mangiare bene e bere giusto” svelandoci che “anche il sommelier du Roi faceva una gran confusione, il famoso Artusi non si occupava che di vivande e quel criticone di Rajberti e l’arte del convitare”.
Se si volessero pubblicare i pareri degli esperti del Sei-Settecento sulla questione che tanto appassiona noi, e di cui a loro non importava nulla, e cioè del saggio accordo fra cibi e vino, si cadrebbe nella monotonia. Più o meno, cuochi e medici che redigono i diversi “regimi sanitari“, ossia i trattati di dietologia d’epoca, seguono quella che potremmo chiamare la “linea” di Sante Lancerio: esame delle qualità organolettiche del vino, e consigli di come berlo, a seconda dell’età, delle stagioni; e i rischi a cui si andava incontro rimandando la data di consumo.
Bisogna attendere fino all’uscita del Cuisinier
Fra i testi più completi, il De naturali vinorum historia del medico Andrea Bacci (prima edizione, Roma 1596) sviluppa l’argomento in ben sei “libri”. Il dottor Bacci era senz’altro un eccellente assaggiatore: lo dimostrano i suoi elogi a un vino, ancora oggi noto solo a pochi gourmets, e cioè il Franciacorta, nel Bresciano. Già allora, quel vino – oggi è uno straordinario Pinot, che nell’azienda di Berlucchi viene elaborato anche col metodo champenois – veniva, in gran parte, esportato in Germania. Né le cose cambiano, quando a occuparsi del vino e del cibo sono i poeti. Nel Bacco in Toscana di Francesco Redi (1685) trovo un solo abbinamento: quello fra il Toscano pomino (anzi, pumino, come scrive il Redi) e il melone, ma solo a Ferragosto (perché a berne sul popone – parmi proprio sua stagione). Quanto ai cuochi, solita indifferenza. Nel 1662 Bartolomeo Stefani dà alle stampe la sua Arte di ben cucinare, dedicata a Ottavio Gonzaga, marchese di Mantova. Pagine e pagine per descrivere i menù, la decorazione della tavola, le statue di zucchero, la piegatura dei tovaglioli: e niente dei vini.
Per farla breve: i primi ad affrontare la questione che ci interessa, sono, almeno in base a quanto mi è stato possibile rintracciare, Viard e Fouret, con il loro Cuisinier. Ottimo, fortunatissimo libro: uno dei cardini della cucina francese, per quasi un secolo, e con 32 edizioni.
Finalmente inizia un ragionamento sugli abbinamenti
E proprio questa resistenza al tempo, a imporre agli autori il continuo cambiamento di titolo: il trattato vede la luce nel 1806 come Cuisinier imperial, e man mano che in Francia si susseguono Napoleone, Luigi XVIII, Carlo X, la Repubblica, Luigi Filippo, Napoleone “quell’altro”, di nuovo la Repubblica di monsieur Thiers, il Cuisinier cambia nome e si fa volta a volta royal, national, di nuovo imperial, in modo da mettersi al riparo da ogni eventuale epurazione. Nella tiratura del 1828, il testo, amplissimo e eccellente, è completato da una Notizia sui vini di M. Pierhugue, sommelier du roi. Sono appena sei pagine, aperte da un catalogo dei vini di tutto il mondo (fra i sei italiani, un nome interessante, Picoli, il famoso Picolit al quale, oggi, stiamo dando la caccia): e una di esse è dedicata agli abbinamenti.
C’è già la base del discorso che verrà portata avanti nei decenni successivi: un ragionamento dal quale dobbiamo dedurre o la nostra incompetenza, o quella dei nostri antenati. Anzitutto, con il potage, va servito un bicchiere di Madera secco. Troviamo la stessa prescrizione in Brillat Savarin (Fisiologia, capitolo Du plaisir de la table, pranzo da lui offerto ai due vecchi scapoli di rue du Bac): si attribuisce il merito di quella moda a Talleyrand, ministro degli esteri, che “avrebbe importato da poco questa usanza”, assieme a quella di cospargere la minestra con parmigiano grattugiato.
L’ordine di servizio comincia dai rossi
Poi, il sommelier del re non ha dubbi: le “convenienze del gusto e della Salute”, impongono di iniziare il servizio con i vini rossi. La serie verrà aperta dai Borgogna meno impegnati, e cioè dai Macon e Auxerre, seguiti dai più solenni Volnay, Chamberlain e, immancabili anche allora, i diversi crus della Romanée. Eccezione: se si inizia il déjeuner con delle ostriche, è facoltativo cominciare con un vino bianco, Chablis, Pouilly o Montrachet (Brillant Savarin, con i frutti di mare, serve, nella colazione su ricordata, il Sauterne).
Dopo tutta la “parata” dei borgogna, che accompagnavano, ovviamente, gli antipasti e le entrées, arriva il “pezzo forte”, l’arrosto: con quello, il tecnico Pierhugue non ammette scappatoie, ci vuole lo champagne, che “ravviva il sapore monotono delle carni arrostite”, e prepara il convitato all’arrivo dei grandi vini, non dice serviti con quali piatti, ma, si suppone, fricassee, pasticci, e quelli entremets del servizio “alla francese” che andavano dal cavolfiore in salsa bruna e dalle cipolle in agrodolce, alla gelatina d’arancio e ai pets de nonne.
Una certa confusione
È il momento, prescrive il sommelier, prima dei vini bianchi – Château Grillè, Hermitage – poi dei grandi “rossi” di Bordeaux, specie del Medoc, al quale vanno le preferenze dell’esperto. Si finirà il pasto con Malaga, Xeres, o almeno Moscati di Lunel e di Frontignan. Ma non si è ancora concluso: dopo il caffè, anzi il Moka, dovranno arrivare le bottiglie “in cui si agita la Follia”, vale a dire degli altri champagnes: e infine, nei piccoli bicchieri, si servirà il Tokai.
Una sola scusante, per giustificare, in parte, questa specie di guazzabuglio: come si è accennato, il servizio era, allora, quasi sempre “alla francese”: gran parte dei piatti figuravano già in tavola, sulle “alzate” o sui réchauds a carbonella, quando si prendeva posto, e così pure i vini, disposti negli “intervalli” fra un piatto e l’altro. Ognuno finiva per farsi servire quanto più gli andava a genio, stabilendo degli “abbinamenti” personali e, per questo, graditi. Una cosa è certa: se, oggi un Anfitrione seguisse la progressiva del Cuisinier royal, la fama dell’incompetente e del confusionario non gliela toglierebbe nessuno.
E in Italia? Le cose non vanno meglio
Mentre questo accade in Francia – ma è, quello di Pierhugue, un caso a sé: il grande Antonio Carema si preoccupava della architettura dei piatti, e non di bevande – gli italiani continuano a non esaminare neppure il problema. Nel 1839, pubblicando il suo celebre trattato di cucina, Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino redige 365 menù, uno per ogni giorno dell’anno: sui vini, neanche una parola.
Poiché, confusione e contraddittorie annotazioni nel trattato di Giovanni Vialardi, cuoco di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II (1854): vermut con le ostriche, Marsala, Madera o Vernaccia sarda con il fritto alle Villeroy o il filetto di bue alla giardiniera, e, il cielo lo perdoni, con il patè di anguilla al burro indifferentemente Sauterne, Hermitage o Barolo. Non c’è da meravigliarsi se, di fronte a questa “disponibilità”, il re galantuomo preferisse, ai banchetti di Corte, starsene (come scriveva Henry d’Ideville) con le mani sull’elsa della sciabola, senza toccarci cibo, in attesa di rifarsi con i piatti popolareschi preparati per lui, a casa, dalla bela Rosin.
E il grande Artusi? Si dedicava solo alle vivande
Neanche i menù dell’Artusi (siamo nel 1891) si preoccupano di certe piccolezze: il gastronomo di Forlimpopoli è l’unico a stabilire cosa si debba mettere in tavola nel giorno dello Statuto, ma solo per quanto riguarda le vivande.
Una testimonianza interessante sui gusti enologici della borghesia italiana di metà ottocento ci viene da un libro, un tempo fin troppo celebre, e di cui oggi non si parla quasi più, l’Arte di convitare del dottor Giovanni Rajberti, un medico milanese convintissimo d’essere un umorista cui spettasse, secondo la formula castigat ridendo, insegnare le buone maniere ai meneghini (e agli altri).
Ve ne parleremo, per ragioni di spazio, nella prossima e conclusiva puntata di questa nostra breve storia del “mangiare bene e bere giusto”; in cui si vede che l’arte del “bere giusto”, almeno dal nostro punto di vista, non ha certamente più di un secolo.
Massimo Alberini, giornalista e critico gastronomico