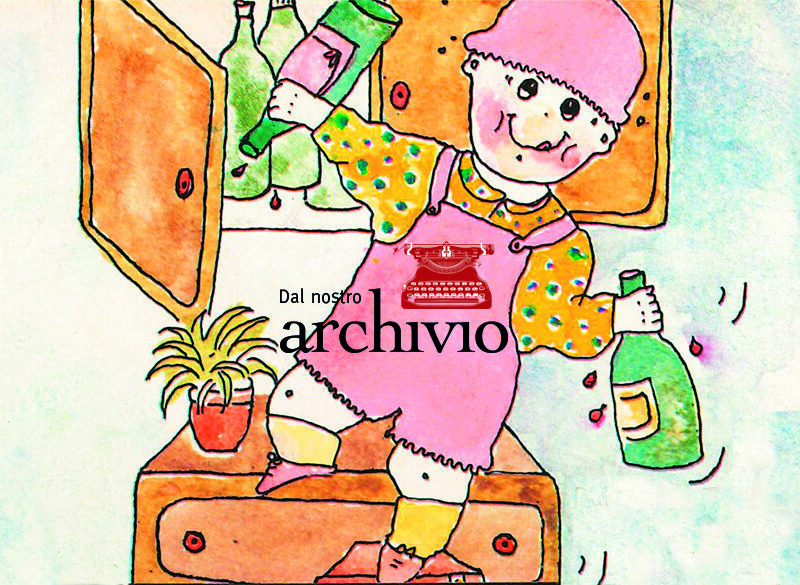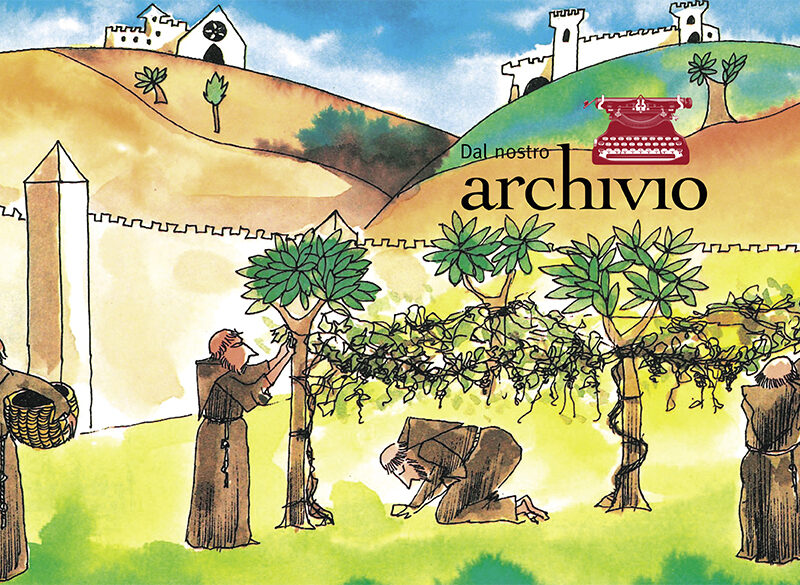Sfogliando i vecchi numeri della rivista, ci siamo imbattuti in una serie di servizi firmati da importanti scrittori e saggisti dell’epoca, che abbiamo deciso di riproporre per il loro valore letterario, oltre che giornalistico. In questo articolo tratto dal n.3 del 1974 il giornalista e regista Dino Falconi ricorda illustri esempi di bevute autentiche coronate dai più caldi applausi del pubblico.
A me, quando a teatro sento cantare “Viva il vino spumeggiante” e “Libiam nei lieti calici” o declamare “Chi non beve con me peste lo colga”, viene la rabbia. Io so benissimo che il bicchiere brandito dal tenore di “Cavalleria rusticana”, i calici levàti dai coristi della “Traviata” o la coppa portata alle labbra da Neri Chiaramantesi nella “Cena delle beffe” sono vuoti e dunque non ci può bere nessuno. E mi fa rabbia perché secondo me il vino è una cosa seria e non mi garba che venga trattato così alla leggera.
Il fatto è che sul palcoscenico, a sipario alzato, non si beve quasi mai. Prima di tutto perché una sorsata potrebbe andare di traverso con relative noiose conseguenze di tosse; in secondo luogo perché nei bicchieri, nei calici, nelle coppe chissà che cosa diavolo ci ha messo il trovarobe, unico responsabile di quanto si porta in scena, dai fiori che annusa la prim’attrice al second’atto al pugnale che si immerge nel petto il prim’attore all’ultimo atto, dal testamento che legge il padrenobile ai sigari che ruba il maggiordomo, da quel che mangia il “brillante” a quel che bevono (o fingono di bere) tutti
L’evoluzione del vino sulla scena
Un tempo il vino, nelle bottiglie, nelle caraffe o in qualsiasi recipiente trasparente, era approssimativamente rappresentato da varie coloriture di acqua e caffè; scure per il vino rosso, chiare per il vino bianco nonché per tutte le bevande alcoliche, dal porto al cognac. Era il tempo delle scene di carta, con le camere e le sale le cui pareti si gonfiavano e palpitavano a ogni chiusura di porta. Tempi eroici, quando i mobili venivano noleggiati di volta in volta in ogni “piazza” e così si vedevano certi saloni cinquecenteschi arredati con poltrone Luigi XV e divanetti “Impero”.
Poi le messe in scena si fecero più rispettabili. Le pareti divennero di stoffa o di cartapesta, le porte di legno e i cancelli non più di ondeggiante carta acconciamente dipinta ma di plastica piuttosto resistente. Le compagnie viaggiavano con mobili di loro proprietà oppure li affittavano dai mobilieri più rinomati se non dagli antiquari più apprezzati. E allora si impose al povero trovarobe di fornire un “falso vino” più verosimile. Fu l’epoca dell’amarenata per i vini rossi e della cedrata per quelli bianchi e i liquori. Che si trattasse comunque di vino vero era da escludersi recisamente e non ne ho mai capito la ragione. Dicevano che le bevande di gradazione alcolica anche bassa erano quelle che più facilmente andavano controgola.
Tesi quanto mai sballata e lo dimostra il caso d’un noto attore, assai applaudito nelle tragedie e nei drammi storici dai pubblici di provincia, Giulio Tempesti, che nelle sere in cui non si sentiva sufficientemente in forma esigeva che gli si facesse trovare fra le quinte, a portata di mano, qualche capace bottiglia di Chianti o di Barbera dalla quale egli tracannava a garganella abbondanti sorsate non appena poteva uscire di scena, fosse pure per un istante. E mai una volta fu colto da accessi di tosse. Tutt’al più – dicono – certe sere pareva un po’ malfermo sulle gambe.
Lo spumante per lo champagne
D’altronde giunse anche il tempo che la teoria del “vino-che-andava-di-traverso” venne clamorosamente smentita dalle esigenze dei registi delle compagnie primarie, i quali pretesero che quando in scena si doveva bere champagne non si mettesse più nelle bottiglie acqua tinta con aggiunta di bicarbonato e cremor di tartaro di modo che, sturandole, il liquido “busciasse”, ma si adoperassero invece bottiglie di vero spumante, magari appiccicando al posto delle modeste etichette originarie i cartigli delle più pregiate marche francesi. Qualche trovarobe conservatore tentò di sostituire lo spumante con la birra, ma senza successo, anche perché in genere alle attrici la birra non piaceva e si rifiutavano di berla. Comunque a fare da champagne era per lo più un moscato di poco prezzo e di bassa gradazione alcolica, tanto per essere sicuri che in scena non si sbronzasse nessuno.
L’epoca dei vini di marca in scena
Infine venne anche il tempo di cui, nel corso dello spettacolo, agli attori in scena si servirono autentici vini di marca. Fu, se la mia memoria non falla, a Milano, nel 1931, sul palcoscenico del teatro Filodrammatici, in occasione della “prima” della commedia musicale ungherese “Wunder bar”. Veramente non è esatto dire “sul palcoscenico”, giacché per le recite di quel lavoro il Filodrammatici era stato trasformato in una sorta di night-club, con tanto di pista per le danze, di podio per l’orchestrina-jazz e di “attrazioni” internazionali. In platea erano stati sistemati tanti tavolini ai quali sedevano gli spettatori che facevano, così, da frequentatori del locale.
E, accanto ai tavoli degli spettatori, sedevano anche gli attori che prendevano parte alla recita. Fra questi ultimi era Arturo Falconi, mio zio nonché fratello maggiore di mio padre Armando, il quale impersonava il proprietario e animatore del “Wunder bar”, mentre Arturo figurava esser uno dei clienti.
Una questione di famiglia
A questo punto bisogna – come nei vecchi romanzi di appendice – fare un passo indietro. Benché i fratelli Falconi fossero entrambi attori ed entrambi applauditi interpreti di parti comiche, essi non avevano mai recitato insieme. Arturo, però, in cuor suo aveva sempre ardentemente desiderato di comparire alla ribalta accanto al fratello che era minore d’anni ma maggiore di fama; sennonché, per un complesso di ragioni indipendenti dalla volontà di tutti e due, quel desiderio non si era mai potuto avverare. Si avverò, per combinazione, con le rappresentazioni di “Wunder bar”. E il buon Arturone non stava in sé dalla gioia di recitare finalmente al fianco del suo caro Armandino.
Il diavolo, tuttavia, mise la coda in quella felicità, perché gli interpreti dello scapigliato spettacolo erano obbligati a bere sotto gli occhi, ma che dico, sotto il naso degli spettatori calici su calici di autentico vino spumante. E si trattava d’uno spumante di grande marca, perché la casa produttrice approfittò dell’occasione per fare pubblicità al proprio prodotto.
Arturo Falconi, come voleva il suo personaggio, doveva sedere a un tavolino e consumare enormi piatti di tagliatelle alla bolognese, annaffiandoli con varie bottiglie di spumante. Ora mio zio, come tutti gli attori del suo tempo, non toccava mai cibo, quando prendeva parte a una prémière, se non a recita finita. Egli dunque si trovò alla “prima” di “Wunder bar” con una fame da lupo e le tagliatelle gli fecero comodo. Ma col mangiare, gli venne sete e con la sete, bevve. Lo spumante era ottimo; la sete, aguzzata dall’emozione della prémiére e dalla gioia di recitare accanto al fratello era tanta. Per farla breve, Arturo si sbronzò; e sbronzandosi, si arrabbiò per essersi sbronzato; e, arrabiatosi, tornò a bere per spegnere la rabbia. Cosicché come succede quando ci si sbronza e ci si arrabbia, andò a finire che dette in escandescenze.
Il lieto fine
Armando, secondo quanto esigeva la sua parte di “padrone del vapore”, doveva metterlo alla porta. Ma il povero Arturo – che aveva ormai perso la trebisonda – gli saltò al collo, aggrappandosi pesantemente e balbettando: «No! Lasciami stare qui, sii buono! Sono così contento d’essere con te! Non mandarmi via, va là!».
Mio padre, che non si aspettava tanta resistenza e che, d’altronde, aveva capito come stavano veramente le cose, cercò di liberarsi dall’abbraccio e di spingere energicamente via il fratello. Niente da fare: fra le risate del pubblico, convinto di assistere a una scenetta combinata, i due fratelli rotolarono in terra e a trasportar fuori quasi di peso il povero Arturone dovettero pensarci un paio di “maschere”.
Naturalmente, a recita finita, i due fratelli erano furibondi. L’uno – mio padre – perché si vergognava per mio zio; l’altro – mio zio – perché non si dava pace d’esser dispiaciuto a mio padre. Ma vedete un po’ che cos’è mai il teatro: l’impresario dello spettacolo si precipitò a scongiurarli di ripetere per tutte le repliche del lavoro quell’imprevisto e irresistibile “fuori programma”. Il che, si sa, puntualmente avvenne.
Be’, quando mio zio raccontava agli amici il buffo episodio, soleva immancabilmente concludere con queste parole: «Tutto sommato, lo ammetto, la cosa finì bene. Ma io, capirete, da quella volta in poi non ho più…» «Non hai più bevuto vino?», lo interrompeva il solito qualcuno. E lui ribatteva allegramente:
«Tu sei matto! Io, da quella volta, non ho avuto più occasione di recitare con Armando. Ma il vino ho seguitato a berlo. Eh, caro mio, il vino è una cosa seria!»
Dino Falconi, scrittore e regista italiano (1902 – 1990)