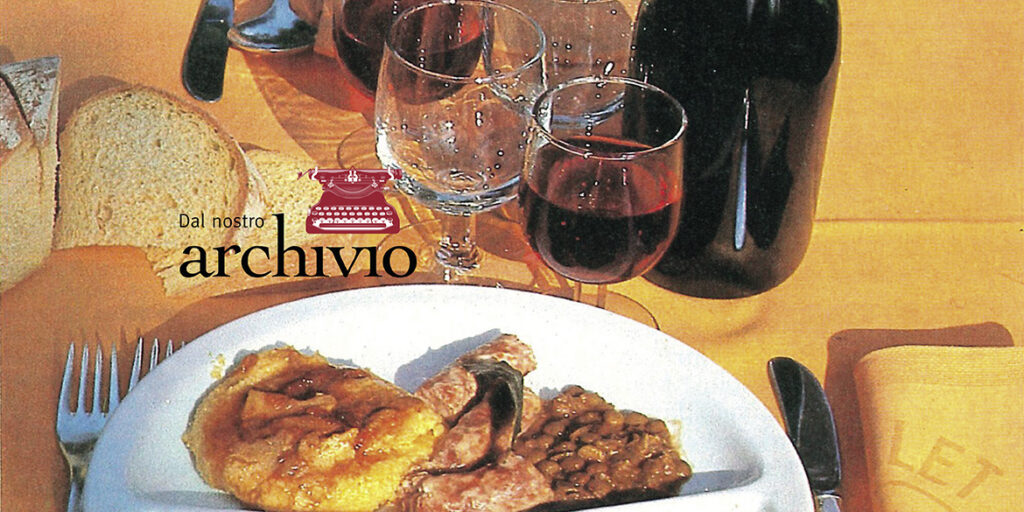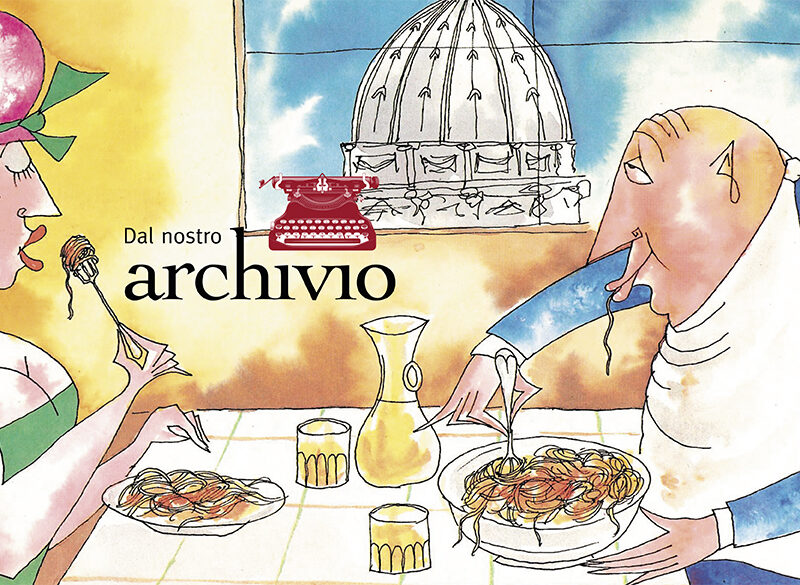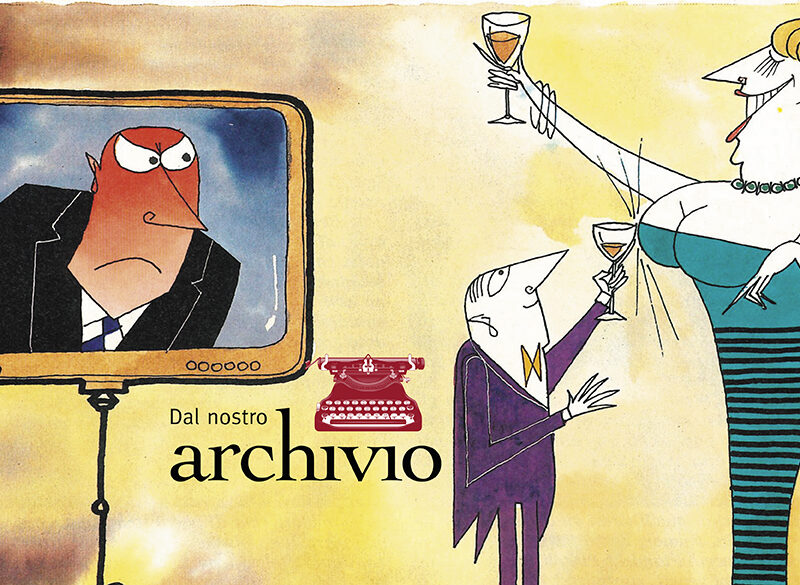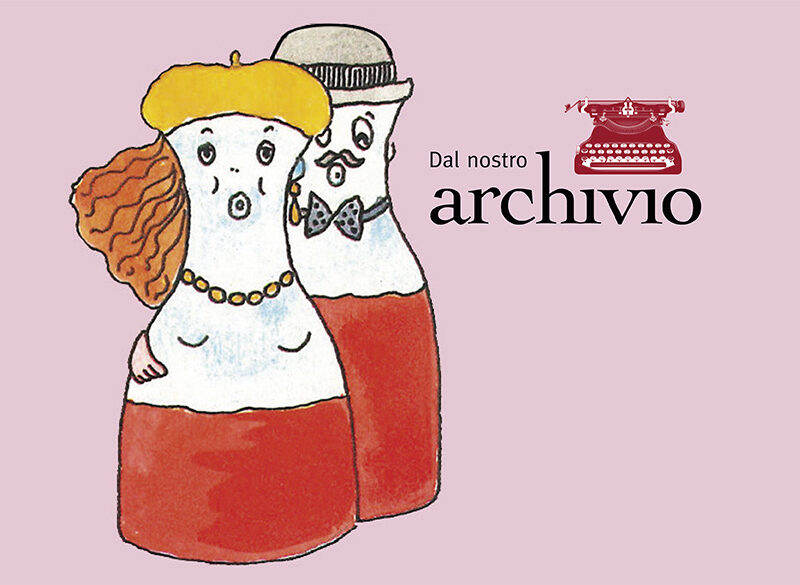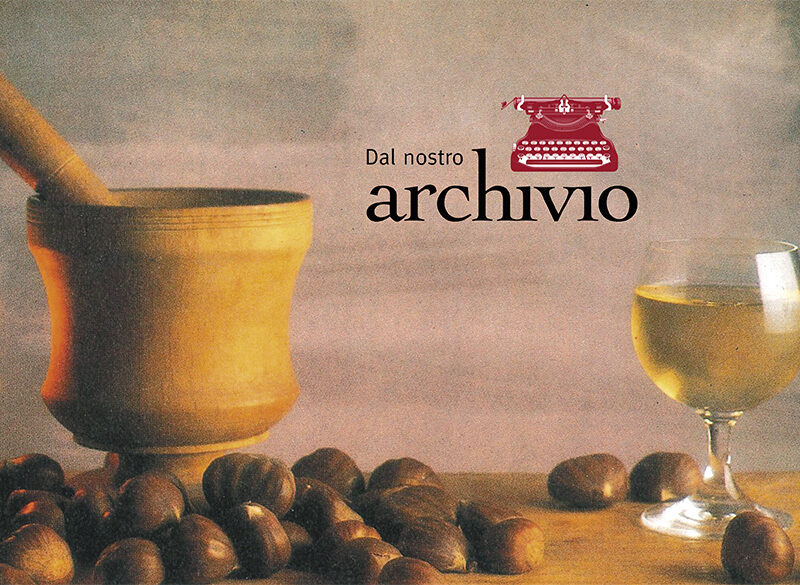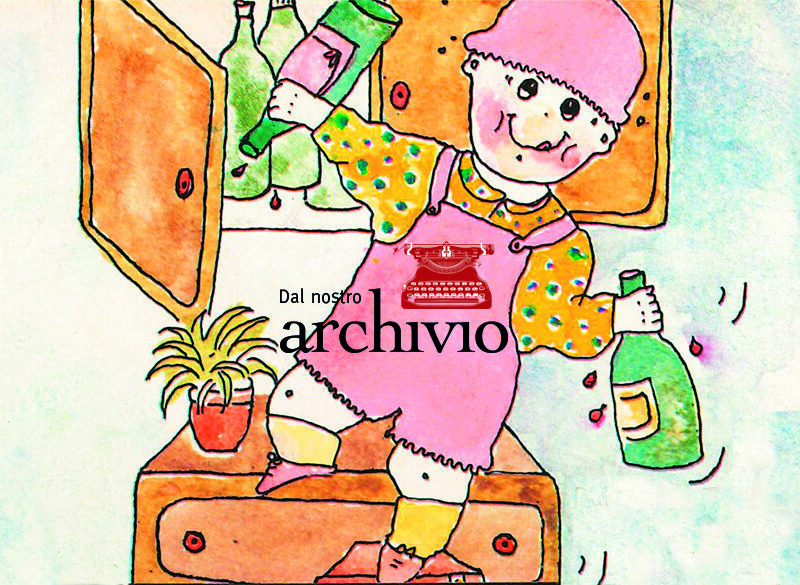Questo articolo del 1982 firmato da Antonio Piccinardi (grande esperto di enogastronomia e autore di numerosi ricettari e saggi) parte da una serie di premesse storiche per esaminare la tipologia delle vivande e dei vini, gli stimoli gustativi e olfattivi e la successione delle portate a tavola
Col pesce si beve vino bianco, questo ormai lo sanno tutti; molti però, in fatto di abbinamento di cibi coi vini, non vanno più in là. L’argomento è sovente trattato, per così dire, a orecchio; e invece, se approfondito, rivela sottigliezze, risvolti e persino un’insospettata base scientifica.In una serie di articoli, Civiltà del bere si propone di affrontare in maniera organica, con intento didattico e divulgativo, la tematica del giusto accoppiamento cibo-vino. Dopo una breve indagine storica, e un’analisi dei meccanismi e delle simbologie dell’alimentazione, entreremo nel vivo del tema esaminando la tipologia dei cibi, la tipologia dei vini, la tecnica dell’abbinamento, la successione dei cibi e dei vini a tavola.
Verrà poi la metodologia dell’accostamento e infine la scheda, cioè la “formula” – che viene proposta per la prima volta – per far sposare, non più da orecchianti bensì con metodo, cibi e vini in armonia. Questo primo articolo introduce l’argomento con cenni storici e s’inoltra poi nelle simbologie dell’alimentazione.
Il ruolo di olfatto e gusto
Una delle principali funzioni della vita biologica è la nutrizione. Sembra di conseguenza coerente fare ricerche affinché venga adempiuta nel migliore dei modi. L’edonismo ci spinge alla ricerca qualitativa delle caratteristiche dei cibi e dei vini. È stato sufficiente, dopo aver interpolato i “dati del piacere”, coordinare per similitudine le sensazioni provocate dai cibi e dai vini per far nascere la metodologia dell’abbinamento.
Cibi e vini provocano soprattutto stimoli olfattivi, dai quali nascono sensazioni che purtroppo nei tempi moderni hanno perduto d’importanza. Esse hanno viceversa avuto nel passato ben maggiore rilievo. Per quale ragione olfatto e gusto debbono essere considerati sensi di minor importanza? O perlomeno incapaci di recepire sensazioni nobili, come quelle percepite dalla vista e dall’udito? Mangiare e bere in un certo modo, vuol dire tenere in considerazione gli stimoli olfattivi e gustativi, vivere di conseguenza con un particolare stile, fare delle scelte, avere delle alternative, e tra queste trovare la composizione ottimale. Il desiderio di cibarsi e dissetarsi con piacere ha un vero bagaglio storico.
E quello della letteratura in cucina
In particolare agli uomini di lettere italiani è toccato il privilegio di creare la letteratura culinaria. Gli apporti sono stati sia individuali che collettivi, in un crescendo continuo che è giunto sino al Rinascimento; epoca che è prevalsa sulle altre, per quanto riguarda lo splendore della cucina, le ricerche e il numero dei trattati di questo argomento.
Notevoli e di particolare interesse sono anche i trattati precedenti. Già alla fine del XIV secolo Simone Prudenziali, con Il Saporetto, nel descrivere gli usi conviviali si occupa della successione delle vivande nel corso di un banchetto e dell’elencazione dei vini.
Tortelli in scutella e bramangeri (1),
suppa francesca (2), lasagne e intermesso (3),
raviol prima o poi ce venne ‘l lesso,
poili, somata (4), segnali (5) e pevieri (6).
Poi capriuoli e lepori in civieri (7),
tordi, piccioni, starne arosto apresso,
cum vin vermigli et arance cum esso (8),
poi palmiscione (9), tartare e pastieri (10).
Bianchi savori (11), verdi e camellini (12),
composta (13), olive conce (14) qui se pone
per far nostri apetiti agusi (15) e fini.
Pere cotte e tragea quive sone,
uva passa, mele appie (16) e nocelline (17),
poi anace (18), confetta (19) e ‘l ciantellone (20)
Apresso questa corte bevèn vin
che se fussor vernacce di Corniglia (21)
bastara, tanto a lei se rasomiglia,
o trebbian marchegiani (22) o grechi (23) fini,
ribbona cotta (24) e moscatel marini
de l’isola de Creti o de Ciciglia (25)
et a le fiate chieriera vermiglia
e monterosso (26) e corsi usamo quini.
1) Bramangeri: biancomangiare. 2) suppa francesca: zuppa alla francese. 3) ‘ntermesso: vivanda d’intermezzo. 4) somata: lonza di porco sotto sale. 5) segnali: cinghiali. 6) pevieri: uccelli trampolieri. 7) in civieri: in salsa. 8) cum esso: insieme. 9) palmiscione: sorta di dolce. 10) pastieri: pasticcini. 11) Bianchi savori: varie qualità e colori dei “sapori”. 12) camellini: di colore brunastro. 13) composta: conserva di frutta. 14) olive conce: olive in salamoia. 15) agusi: aguzzi. 16) mele appie: mele-pere. 17) nocelline; nocciuole. 18) anace: anice. 19) confetta: confetti. 20)1 ‘l ciantellone: un bicchiere di vino. 21) vernacce di Corniglia: Vernaccia di Corniglia, delle Cinque Terre, in Liguria. 22) trebbian marchegiani: il Trebbiano delle Marche. 23) grechi: vin Greco di Toscana. 24) ribbona cotta: Ribolla bianca passita, vino del Collio. 25) moscatel marini / de l’isola de Creti o de Ciciglia: vini moscati di Creta e di Sicilia. 26) Monterosso: vino delle Cinque Terre.
Le funzioni delle diverse tipologie di vino per il Platina
Bartolomeo Sacchi detto il Platina descrive con estrema chiarezza caratteristiche e funzioni del vino, per mezzo del suo trattato letterario del XV secolo, il quale è il rifacimento del precedente libro di Maestro Martino Dell’Arte Coquinaria: “il vino generoso stringe il petto e lo infiamma; l’abboccato è invece emolliente, ma senza molto vantaggio, poiché si trasforma assai facilmente in bile acuta. Quello secco è benefico in tutto e per tutto, poiché giova a tutte quante le membra. I vini bianchi, se son secchi e non interamente schietti, si digeriscono più agevolmente di quelli neri.
Questi ultimi infatti stringono le fibre del petto, mentre quelli le rilassano e le ammorbidiscono; i chiaretti in verità si prendono con maggior sicurezza. Il modo di confezionare i vini, che varia a seconda dei Paesi, lo si chieda agli agricoltori esperti delle singole regioni. Quanto a noi, è sufficiente che passiamo in rassegna i vini maggiormente pregiati. Ma prima desidero esortare i lettori a non credermi per questo un bevitore di vino, poiché non c’è nessuno che più di me, per principio e per natura, faccia uso di vino allungato”.
Una prima scelta
Dal brano che segue e dalla frase “soltanto così smorzerai il fuoco col fuoco” si intuisce già una scelta di abbinamento per similitudine, ovvero la “violenza” del vino in armonia con la “violenza” del cibo, al fine di ottenere equilibrio tra notevoli strutture. Il brano è di Teofilo Folengo da Baldus della prima metà del XVI secolo.
“Viene allora di seguito, in lunga fila, un’infinità di tazze d’oro e d’argento con ornamenti di gemme, colme di confetti di varia specie, che si convengono alla tavola dei re: al punto che la mensa, carica di tanta abbondanza, sembra stia per piegarsi. Vi sono morselletti (2), anici, pinoli, marzapane e dolci perfezionati in cento battaglie di cuochi. Ma più gradita di tutte queste cose giunge finalmente in grandi vasi l’ostrica fumante (3), a cui si suole accompagnare la malvasia (4), gloria d’ogni vino, in conformità al prudente motto dei padri, che solevano dire: “Soltanto così smorzerai il fuoco col fuoco”.
Non mancò quivi il vino strizzato dai racemi di Somma (5). Somma onore di Napoli e per contro crapula della gran Roma. Quel monte solitario produce infatti un vino, chiamato comunemente greco, che fa andare per traverso ogni brigata.
E insieme vi furono il mangiaguerra (6) e la vernaccia di Volta (7) e quella di cui si vanta la Bresciana Cellatica (8). Quanto alle vigne del trebbiano di Modena, esse non occuparono certo il secondo posto; e così pure la moscatella perugina (9), due vini che riempiono di mille fantasticherie la testa dei panciuti tedeschi.
E non mancarono nemmeno le vendemmie della tua piana, o Cesena (10), né le dolci orine che la Corsica è solita pisciare (11). Questi celeberrimi vini e molti altri erano in grande abbondanza, superiori a quelli dei nostri fiaschi e preferibili a qualsiasi altra bevanda”.
2) morselletti: dolci tagliati a bocconcelli. 3) l’ostrica fumante: si usava servirla calda sul finire delle mense, accompagnata da vini forti e liquorosi. 4) la Malvasia: vino delle Isole Egee, importato in Italia dai Veneziani o prodotto anche da vitigni nostrani. 5) il vino… di Somma: è il vino Greco prodotto nelle campagne di Somma Vesuviana. 6) il mangiaguerra: vino grosso, prodotto per lo più in Campania. 7) Volta: borgata posta sulle colline moreniche dell’alto Mantovano. 8) Cellatica: paese delle Prealpi bresciane. 9) la moscatella perugina: Moscato di Perugia. 10) le vendemmie della tua piana, o Cesena: allude all’Albana, prodotto nella Romagna; rinomatissimo quello di Cesena. 11) le dolci orine che la Corsica è solita pisciare: vini bianchi, evidentemente; molto apprezzati ai tempi del Folengo.
Servizio alla francese vs alla russa
Ma veniamo a tempi più vicini ai nostri. Secondo Leon Maillard, autore di un volume dedicato ai menu, edito a Parigi nel 1898, le prime “liste” apparvero sulla tavola nel 1855 alla corte di Napoleone III. Prima di allora non si avvertiva la necessità di dare per iscritto la successione dei cibi, in quanto il servizio era “alla francese”; gli invitati si sedevano attorno a un tavolo dove erano predisposte tutte le vivande, e si servivano senza regola né successione.L’iniziatore di un metodo nuovo per proporre cibi fu il Principe Alessandro Borisovich Kurakin, Ambasciatore dello Zar a Parigi. Durante i banchetti da lui offerti sulla tavola figuravano solo i fiori e gli elementi decorativi, quindi i valletti passavano da un invitato all’altro offrendo una vivanda alla volta. Il sistema fu apprezzato e detto “alla russa” in contrapposizione a quello in vigore detto “alla francese” o “alla forchetta”. Stabilendo la successione delle vivande venne di volta in volta necessario effettuare una scelta oculata dei vini in coerenza coi piatti proposti e la loro relativa successione; ecco l’evolversi dei gusti e il nascere di un nuovo stile.
La percezione dei cibi
Psicologia, meccanismi e simbologia dell’alimentazione da un verso, edonismo dall’altro, in parte in contrapposizione, alle volte in rapporto complementare, sono il substrato della ricerca inizialmente automatica e inconscia che portò alla formulazione del menu inteso come scelta, modo di vita, comportamento alternativo, idealizzazione di uno stile.
Stabilire un iter dei cibi e dei vini vuol dire conoscere le sensazioni che essi provocano. Così come le bevande ci impressionano per le sensazioni acide e per tutti quegli elementi di morbidezza, zucchero compreso, che fanno l’equilibrio, per le vivande esiste una suddivisione data dagli stimoli che esse provocano. In quanto ai cibi solidi i denti li frantumano, la saliva li aggredisce imbevendoli, la lingua li schiaccia contro il palato per spremere il sugo che sensibilizza le papille gustative. Le esalazioni aromatiche vanno a stimolare in via indiretta gli organi dell’olfatto. Il cibo introdotto nella bocca crea una immediata sensazione possessiva, solidi e liquidi vengono imprigionati, le labbra come gendarmi inflessibili si oppongono alla loro uscita, i denti li tritano, la saliva li impregna, la lingua li preme e li rivolta. Il cucchiaio attua il passaggio dal piatto alla bocca, la sua forma suggerisce morbidezza, ricorda il palmo della mano e opera in termini di rotonda compostezza in un rapporto di equilibrio e morbidezza evitando quasi la rottura tra la crema e la bocca che andrà a riceverla. Le salse che ricoprono carni, pesci, dolci, rammentano fatti di protezione materna, estendendo nel tempo l’illusione di dolcezza fin quando il pezzo solido non emerge dal sotto dell’elemento coprente. Cosi alla fine del pasto le creme, i budini che si inghiottono senza sforzo, i vini morbidi e dolci, ricchi di glicerina, quasi che tutto ciò ricordi le incondizionate, ingorde gioie infantili.
Ad ogni ora il suo alimento
Il meccanismo dell’alimentazione, affiancato dagli stimoli provocati da cibi e bevande, è alla base delle scelte fatte per creare una successione dei cibi e dei vini, nonché l’accoppiamento. Meccanismi e simbologia dell’alimentazione sono stati i primi elementi che hanno indotto i ricercatori a comporre una successione seguendo le sensazioni che i cibi provocano. Così al mattino la proposta di cibi dolci, consuetudinari, tutto sommato di poca fantasia, tali da non riscuotere né impressionare appena destati, la consuetudinarietà dei cibi e delle bevande ricrea un’immediata familiarità con le luci dell’alba, il risveglio diventa quasi una continuità senza elementi ansiogeni. Gli antipasti, in genere stuzzichevoli, o avvolgenti come le mousse, creano sodalizio e allegria tra i commensali, non rappresentano un “impegno”, bensì un fatto transitorio e di approccio e facilitano, per mezzo della loro curiosità e fantasia, il contatto tra i convitati.
Spumanti, bianchi, rosati, rossi e dolci
L’irruenza espansiva degli italiani esprime coi primi piatti la comunicativa più convincente, la morbidezza avvolgente dei risotti, la paciosità delle zuppe, la sensazione di vivacità, freschezza degli spaghetti con la presenza nervosa della pasta e l’elemento aromatizzante della salsa. Gli arrosti seguono provocando la sensazione possessiva data dalla carne che suggerisce voracità e aggressività, per alternare la morbida suadenza delle verdure. A conclusione i dolci soffici, spugnosi, fragranti o con la crema che conferisce voluttà e sensualità, i frutti che suggeriscono sensazioni primitive, che diventano composite se mescolate a liquori o gelato.
Nei vini si avvertono le stesse scale di valori ascendenti, i bianchi freschi, sapidi, o gli spumanti allegri con la capacità di dissetare e predisporre con la loro sapidità al pranzo. I rosati o i rossi giovani irruenti e bonari, golosi, mentre gli invecchiati sono vini “riflessivi”, da ponderare, che esigono una ricerca più attenta; e a conclusione i vini da dessert morbidi, dolci suadenti, quasi confidenziali.
Questi elementi solitamente non considerati da altri ricercatori, sono stati determinanti al fine di predisporre menu e abbinamento cibo-vino. Nel prossimo articolo passeremo dalla teoria alla pratica, esaminando diffusamente la tipologia dei cibi e quella dei vini.
Antonio Piccinardi