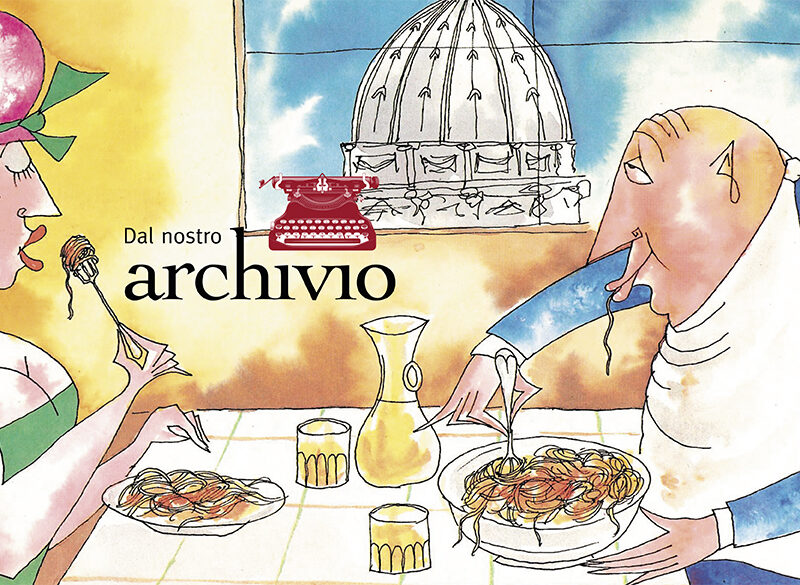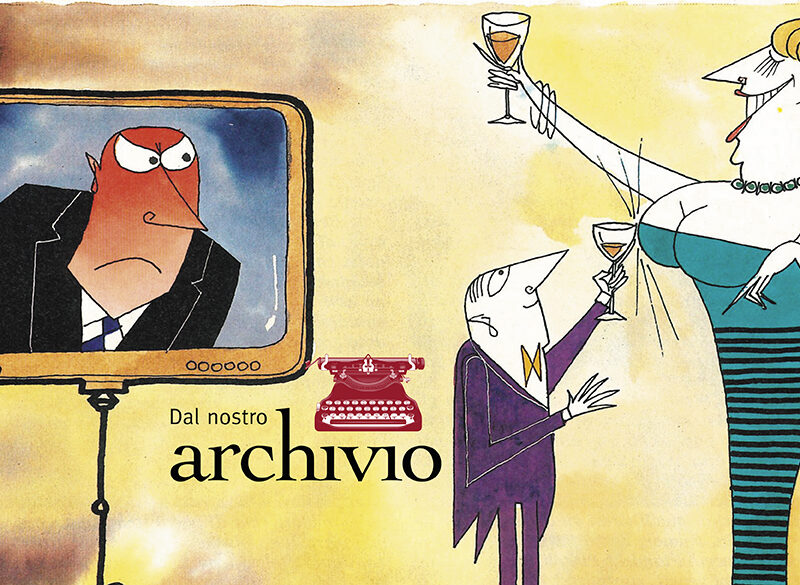Ripubblichiamo un articolo scritto per noi dal piemontese Sandro Doglio, giornalista e autore della rubrica de La Stampa “Il gentiluomo di campagna”. Qui parla dello stesso mondo contadino in cui aveva saputo ritrovare elementi autentici per cui valeva la pena vivere, in un’epoca dove Carlin Petrini e il suo Slow Food erano ancora di là da venire
Un foglio bianco davanti, bene infilato nella macchina da scrivere, e non si sa come cominciare. Oppure la frase che si è messa giù e che sembrava un brillante inizio, letta nero su bianco appare banale, scontata, troppo letteraria. La si butta via e si prova a scriverne un’altra. Ho visto Giorgio Bocca una volta cominciare più di venti volte un articolo e non essere mai soddisfatto. Dicono che Montanelli, invece, si segga alla macchina e picchi sui tasti quasi senza prendere respiro, dall’inizio alla fine del suo articolo: ma sono eccezioni. Le regole del giornalismo vogliono che per prima cosa si scriva “chi, cosa, dove, quando”: ma non sempre si devono raccontare fatti precisi o notizie così ben delineate; è spesso difficile costringere la realtà a stare in caselle.
La ricerca dell’incipit e il rapporto con la natura
Il grande Hemingway – dal quale noi di una certa generazione abbiamo cercato tutti di imparare – sosteneva che si deve cominciare un articolo con la frase più vera, con il riassunto stringato di ciò che si vuole dire: ma lui era Hemingway, e le nostre corrispondenze non sempre hanno messaggi pregnanti da trasmettere. Giorgio Fattori (direttore de La Stampa, ndr) mi dice: “Beato te che vivi in campagna: quando non sai come cominciare un articolo, fai un giro in giardino e cerchi l’ispirazione tra gli alberi e i fiori”. Senza volerlo mi ha dato un alibi per far lunghe passeggiate tra vigne e campi, che forse non risolvono il problema di come cominciare l’articolo, ma certo hanno fatto aumentare e migliorare i miei rapporti con la natura.
Saggezza innata contadina
Quando scrivo da casa, anche se devo raccontare di Somalia, di America o di acciaio in crisi, i miei articoli sono sempre ripensati fra due filari di vigna o nella cantina del vicino che mi ha incontrato mentre bighellonavo in paese, e mi ha invitato a bere un bicchiere “di quello buono”. Capita anche che prima di scriverli io racconti i miei viaggi non soltanto a mia moglie, curiosa e attenta, ma addirittura al mio amico Vito, il contadino della cascina accanto, che trovo sorridente e con la grossa mano tesa appena metto piede a terra, avido di sapere – lui che il mondo lo conosce solo per saggezza innata e per quel che vede alla televisione – che cosa capita e come si vive altrove.
Il tema abituale del vino
Così racconto: frasi stringate, cose importanti; colore e letteratura vanno a farsi benedire. Le domande che mi fa sono essenziali, il problema si riduce all’osso, mi costringe a rispondere con un sì o con un no, a dar giudizi taglienti. Ed ecco che ripensando poi alle sue domande, spesso l’articolo mi rinasce sotto le dite che battono sui tasti della macchina da scrivere. Fra gli interrogativi, alcuni sono ricorrenti; che tempo faceva, come si vive, costa caro; e poi: le donne come sono? Che cosa si mangia? Che cosa si beve? Il vino, soprattutto, finisce per diventare il tema abituale della conversazione, perché è materia che lui conosce, sa come si fa, come si beve, anche se non è produttore per vendere, ma spreme delle sue uve soltanto quelle poche brente che servono alla sua tavola.
Storia della “civiltà del bere” con metro piemontese
Viaggiando, dunque, un pensiero al vino o al bere lo faccio sempre, anche se non sono né grande bevitore né raffinato intenditore; sul mio taccuino, fra appunti di economia e note di storia, frasi dette e cifre raccolte, indirizzi e spunti, annoto anche i prezzi delle bottiglie viste in vetrina, i racconti delle serate passate in ristorante, i confronti con i gusti di casa nostra, i nomi di vitigni e di vini; a volte persino mi capita di disegnare la forma di bottiglie inconsuete scoperte o assaggiate qua e là. Penso che se ne potrebbe trarre una rudimentale storia della “civiltà del bere”. Incompleta, certo, e anche faziosa e partigiana perché fatta a misura dei nostri gusti semplici di piemontesi, sempre confrontata alle poche, grandi famiglie di nostri vini: “È come una Barbera, ma più amabile”. “Non ha però il profumo del Dolcetto”, “Chiaro come un Grignolino vecchio”, “Più caro del Barolo”, eccetera.
Racconti e curiosità di viaggio
Sul taccuino degli appunti c’è la sorpresa per la bottiglia che costa cento dollari, c’è la condanna del Lambrusco in lattina (che adesso vendono anche al supermercato del paese qui vicino), c’è la meraviglia per il gran consumo di bianco che si fa nel mondo (qui in campagna il bianco è poco, spesso è soltanto Moscato dolce che bevono le donne o i bambini, oppure dissetante per i pomeriggi d’estate); c’è la descrizione di come si tendono i tralci di vite nel Veneto o di come sbucano tra i sassi di Châteauneuf. Nei miei racconti hanno un posto d’onore – e stupiscono – le gigantesche bistecche degli Hilton, il serpente o il cervello di scimmia mangiato in Cina, gli spaghetti serviti come contorno in Germania e le fantasmagoriche montagne di frutti sconosciuti del Brasile. Va da sé.
La diversità di usi che stupisce
Ma tutto sommato quel che più stupisce ancora il mio amico Vito è che nei Paesi arabi sia vietato il vino, che i cinesi pasteggino bevendo tè, che in America addirittura i grandi si comportino come i ragazzini di città che vengono al paese per le vacanze d’estate: un bicchiere di Coca-Cola a tavola, punto e basta. A ben pensarci, perché non stupirsi, perché non trarne conclusioni e giudizi di diversità, spiegazioni di caratteri e di storie tanto differenti? Non c’è proprio nella differente, atavica, abitudine a certi tipi di bevande, una spiegazione a caratteri e “civiltà” tanto differenti? Lasciando l’interrogativo ai sociologi, l’ipotesi è comoda soprattutto quando ci si trasforma in cronisti un po’ faziosi, prepotenti nell’interpretare i fatti, con l’esigenza di dar spesso una spiegazione concreta, semplicistica e anche un po’ seducente.
Denominatori comuni
Pensandoci, mi viene il radicato sospetto di avere troppo spesso fatto sommaria giustizia – nel raccontare i viaggi davanti a un bicchiere di Barbera agli amici del paese – di tante spiegazioni; di avere dimenticato dati e riferimenti, di avere un po’ forzato le interpretazioni per rendere più comprensibili le cose, riducendole ai denominatori comuni del mangiare, del bere, delle donne, dei prezzi, delle case… soprattutto del vino. Temo di aver fatto diventare i tedeschi più pesanti perché bevono tanta birra, di aver impoverito i già poveri nomadi dell’Oltre Giuba perché non hanno neppure la possibilità di bere un bicchiere di rosso, di aver reso più ingenui gli americani perché pasteggiano a Coca-Cola, di aver fatto sognare la Spagna perché dappertutto a Madrid si può trovare un calice di “tinto”.
Un mondo deformato dal vetro del bicchiere
E Venezia è certo più attraente, nei miei racconti, per merito di quella bottiglieria vicino a Rialto dove ogni volta vado a bere un’ombra di Cabernet. I francesi sono furbi perché vendono care le loro bottiglie; i greci sono in decadenza perché aggiungono resina al succo d’uva; russi e polacchi riescono a sopportare la dittatura perché l’annegano nella vodka, gli scozzesi sono simpatici perché sono riusciti a inventare il complicato modo di fare il whisky, e gli svedesi sono poveretti e portati al suicidio perché gli è quasi vietato bere. È un mondo deformato dal vetro del bicchiere. L’obiettività va a farsi benedire; avvenimenti e caratteri si trasformano, si adattano alla chiave di interpretazione che più ci piace e che ci appassiona.
Le feste dell’uva
Siamo in fondo – noi del paese, e di questa età – gente che il vino prima ancora di berlo l’ha fatto, schiacciando, ragazzini con i piedi nudi, i grappoli ammassati nel tino, fra risa e canti sull’aia della cascina in cima alla collina. Festa e rito che non ci sono più, ma che ci sono rimasti nel sangue oltre che nei ricordi dell’infanzia. A ben pensarci, di tutto quel che c’era nella nostra prima giovinezza, forse l’unica cosa rimasta è proprio il vino; non si passano più le sere d’inverno nella stalla a legare i rami per far le ramazze; non c’è più la festa dello spogliare le pannocchie di granoturco; non si va più con il carro trainato dai buoi a portare le fascine di canapa a marcire nelle acque morte della valle.
Riti dimenticati e non
Le donne del Monferrato non coltivano più lo zafferano di cui coglievano con pazienza certosina gli stimmi rossi che vendevano poi seccati all’omino che arrivava verso Natale e che li pagava letteralmente a peso d’oro, dopo averli pesati con il bilancino da orefice che si portava appresso. Nelle notti d’estate non si dorme più cullati dal cri-cri dei bachi da seta che divorano le foglie fresche del gelso sui telai di canna messi accanto al letto.
Di tutto questo forse resta proprio soltanto il vino, anche se non lo si pesta più con i piedi, anche se per qualcuno è diventato industria. Un bicchiere di vino è la cosa che assomiglia di più alle cose che si ricordano di quando eravamo bambini; tutte le altre sono cambiate, scomparse, plastificate: iconografie morte di un tempo che non c’è più.
Il valore simbolico del vino
Si può misurare il tempo che cambia prendendo proprio il vino come metro, come riferimento? Quando nascono i figli si mettono da parte bottiglie dei vini di quell’anno, testimonianza per il giorno in cui si sposeranno, in certi casi addirittura si conservano perché qualcuno le stappi il giorno dei funerali, e davanti a un bicchiere di quel vino ormai morto anche lui, spesso inacidito, senza più quasi colore, possa vedere e sentire – con gli occhi, con il naso e con il palato – tutto il tempo che è passato. I pensionati che dopo lunga emigrazione in città tornano in paese, non riaprono più la vecchia stalla dei nonni, non scendono più a valle per seminare meliga e grano, ma un tentativo almeno con la vigna lo fanno: per avere un po’ d’uva, e farsi il “loro” vino, simbolo del fatto che sono di nuovo quassù, che sono ancora vivi.
Il metro del vino
Così passa il tempo fra queste colline. Siamo portati a misurare con il loro vino, con il loro bere, la civiltà degli altri, e prendiamo il metro del vino per valutare la nostra, e gli anni che se ne vanno, e quelli che verranno. Il metodo si presta a sbagli, a volte anche a distorsioni gravi: ma è anche un bel gioco, di cui conosciamo bene regole e carte, e in fondo anche i limiti. Dunque: da dove vieni, Sandro? E come si vive laggiù? Come sono le donne? Che cosa si mangia? Che cosa bevono?
Sandro Doglio